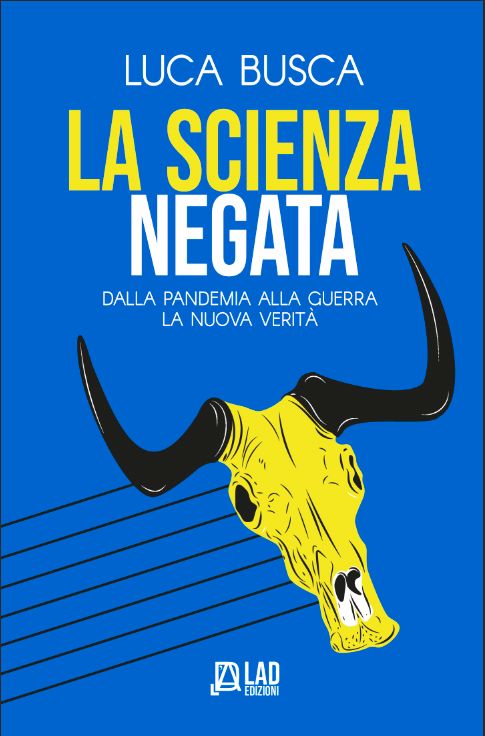LA RIFORMA COSTITUZIONALE E LA DERIVA AUTORITARIA DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO
di Carlo Amirante*
L’Assemblea dei cobas del 1° maggio 2016 è stata l’occasione di una severa e proficua riflessione sulla situazione sempre più precaria del lavoro nel Mezzogiorno dovuta al venir meno del progetto FIAT di rilanciare la produzione automobilistica e quindi l’occupazione, con la prospettiva più che concreta di ulteriori riduzioni di personale.
La strategia di decentramento produttivo della Holding Fiat altro non è stato che una conseguente applicazione della formula neoliberista della “distruzione creativa”, praticata con cinismo contro la classe operai meridionale, con il sostegno, e in ogni caso con l’inerzia sia del governo che dei sindacati confederali, che non hanno imposto al governo di svolgere un irrinunciabile ruolo di mediazione nei confronti di un’impresa come la Fiat (Group Automobiles S.p.a. PI) che si è sempre giovata, come lo stesso Avv. Agnelli ha riconosciuto di appoggi e favori dai governi che si sono succeduti dal dopoguerra, sindacati che da ultimo si sono addirittura schierati a favore delle scelte di Marchionne.
Risalendo alle vicende che hanno caratterizzato le grandi trasformazioni nei rapporti fra capitale e lavoro, a partire dalla svolta dell’ EUR, passando per la politica dei sacrifici proposta da Lama in più occasioni, e in particolare in un’intervista a cura della CGIL particolarmente eloquente, l’assemblea ha stigmatizzato con lucidità i progressivi cedimenti delle confederazioni sindacali - nessuna esclusa - alle esigenze e alle strategie del padronato di cui l’episodio più eclatante è stato probabilmente l’acquiescenza della UIL in occasione del referendum sulla scala mobile proposto dal governo Craxi che ne sancì l’eliminazione.
In un clima politico e sociale in progressiva trasformazione è venuto meno il ruolo di mediazione dello stato (e delle sue istituzioni) fra capitale, imprese e lavoro; così il ripiegamento sempre più accentuato dello stato sulle esigenze, i bisogni e gli interessi del capitale finanziario e di un capitale industriale sempre meno autonomo nei confronti dalla grande finanza e delle Banche, ha prodotto una specie di “azione istituente” di nuovi rapporti di forza ai danni dell’autonomia operaria (ossia una rifunzionalizzazione delle istituzioni nazionali ai dogmi del neo-liberismo). Si è fatta così terra bruciata di decenni di lotte e di conquiste, un fenomeno che a giudicare dagli esiti a cui siamo arrivati oggi si può definire un’autentica “rivoluzione”! Una rivoluzione che si è progressivamente rivestita di norme giuridiche, destinate a formalizzare e stabilizzare nuove relazioni sindacali che cercano d’imporre arretramenti progressivi su posizioni che sono sempre più compiacenti alla visione padronale; una visione considerata l’unica compatibile con i dettami del mercato e con gli orientamenti imposti da Organizzazioni ed Agenzie globali alle quali si adeguano con rigore ancora maggiore le istituzioni dell’ Unione Europea.
Un esempio lampante di una progressiva dipendenza delle politiche nazionali da quelle comunitarie è l’ormai famosa e citatissima lettera della BCE al governo italiano del 5 agosto 2011, in un momento di drammatica crisi economica del nostro Paese, con cui s’imponevano al governo in carica non solo le scelte di politica economica e finanziaria, ma anche una ridefinizione del ruolo e delle funzioni delle istituzioni nazionali. Così si è imposto addirittura allo stato col cosiddetto fiscal compact (ossia il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione Economica e monetaria del 2 marzo 2012), di “rafforzare i pilastri economici dell’Unione Economica e Monetaria, adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio, a potenziare il coordinamento delle politiche economiche e sociali nazionali, pretendendo di sostenere in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di crescita sostenibile…”, cioè l’ “.. occupazione, la competitività e la coesione sociale”!
In concreto l’Europa sembra volere uno stato che non è più un’entità esogena, un soggetto esterno ai conflitti sociali, ma ente assolutamente complementare ed integrato nel sistema degli scambi e del mercato rinunciando definitivamente al precedente ruolo di mediazione e di controllo che faceva di governo e parlamento istituzioni responsabili dello sviluppo economico e dell’occupazione.
Si tratta, per fare solo un esempio, di uno stato attento a infondere fiducia nei finanziatori privati dovunque essi siano (anche se all’estero!) piuttosto che a garantire e favorire una sia pur minima redistribuzione della ricchezza e la garanzia dei diritti sociali, a cominciare dal lavoro, così come prevede la Costituzione.
In effetti, dal versante comunitario proviene con sistematica insistenza la richiesta al governo italiano di riformare l’intero assetto legislativo di tutela del lavoro subordinato, con particolare riferimento alla contrattazione fra padronato e lavoratori nel senso di un ampliamento dell’efficacia e della rilevanza giuridica di contrattazione aziendale in deroga alla contrattazione collettiva nazionale, oltre che un ripensamento radicale della normativa concernente l’assunzione e il licenziamento dei lavoratori subordinati, anche del settore pubblico, strumenti tutti funzionali al raggiungimento della piena occupazione..!?!?
Dunque, il nuovo stato neo-liberale si è assunto così il compito di adeguare interi settori della vita sociale alle logiche di mercato, realizzando interventi legislativi che consolidano il potere datoriale indebolendo progressivamente quello dei lavoratori.
Così la riforma del “mercato del lavoro”, a partire dal pacchetto Treu, e in particolare con la legge Biagi del 2003, ha accelerato progressivamente la liberalizzazione delle tipologie contrattuali con le quali assumere i lavoratori dipendenti, con una straordinaria accelerazione in evidente controtendenza con il ruolo di mediazione dello stato; mentre un tempo uno dei compiti fondamentali del governo era quello di intermediario in occasione della firma dei contratti fra datori di lavoro e lavoratori sia pubblici che privati, oggi il governo si rende protagonista della deregolamentazione legislativa di questo fondamentale settore a tutto svantaggio dei lavoratori.
La flessibilità imposta dall’Unione Europea come nuovo modello regolativo del mercato del lavoro, non garantendo quella sicurezza che era considerata il vanto del modello di flexi-security dell’esperienza danese ha imposto, al contrario, il drastico abbattimento delle garanzie e dei diritti consolidati nel corso di lotte politiche e sindacali che avevano fortemente condizionato non solo la legislazione ma anche la contrattazione collettiva.
La rinuncia ad ogni effettiva elaborazione (sia teorica che normativa) di garanzia di sicurezza sociale ha fatto si che la flessibilità si trasformasse in precarietà del lavoro senza affatto assicurare la promessa di maggiore occupazione né quella di miglioramenti salariali.
Così, seguendo questa strategia gli strumenti impiegati per contrastare una disoccupazione, che nel caso dei giovani ha superato la soglia del 40%, i governi degli ultimi decenni hanno prodotto una radicale deregulation del diritto del lavoro: così, dalla legge Fornero al Job Act, si è eliminato per il lavoratore il diritto di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giustificato motivo o giusta causa!
Su un piano diverso sono venute meno le tutele dei contratti collettivi nazionali di categoria, perché l’art. 8 della legge n° 148 del 2011 consente ora alla contrattazione aziendale di derogare alle garanzie da essi previsti, a sfavore dei lavoratori; mentre per quanto riguarda i pubblici dipendenti, una recente sentenza della Corte di Cassazione ( 11868/2016 ) ha stabilito che ai dipendenti pubblici in caso di licenziamento illegittimo non si applica l’art.18 della riforma Fornero, ma la versione precedente fino a quando i regimi del lavoro pubblico e di quello privato non verranno armonizzati.
Su un piano più generale, ciò che colpisce tanto nel dibattito politico quanto in quello scientifico - soprattutto nel campo delle cosiddette relazioni sindacali, nel quale la stessa terminologia tende a mistificare il rapporto fra impresa e lavoratori, parlando ad esempio di social partners - è la l’inadeguatezza della prospettiva politico-costituzionale. Questa quasi sempre si riferisce a singole norme della Costituzione, finendo così per perdere di vista quella trasformazione radicale del modello economico-sociale previsto dalla Costituzione, la cui trasformazione è avvenuta parallelamente all’autentica rivoluzione del modello politico-istituzionale che è passato dal governo rappresentativo ad un modello di governance tecnocratico-manageriale allineata ai modelli globali e comunitari di gestione dell’economia.
Si tratta di un autentico stravolgimento del nostro sistema costituzionale alla base del quale – come hanno spesso lamentato i critici più radicali del welfare state – c’era una visione realistica del modo di produzione capitalistico, fondato sul lavoro, come struttura portante di un intero sistema economico nel quale la tutela del mercato e della concorrenza non era il principio/valore prioritario e performante l’intera organizzazione dei rapporti economici e sociali. Così la rigorosa tutela salariale prevista dall’articolo 36 della Costituzione, per cui il salario non solo doveva corrispondere alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma essere anche tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, ha trovato riscontri, grazie alle lotte politiche e sindacali di almeno un trentennio (dal dopoguerra agli anni settanta), in riforme di carattere economico e sociale ( dallo Statuto dei Lavoratori alla riforma della scuola, della salute, dell’università, ecc..) e in una contrattazione collettiva che spesso anticipava e imponeva le riforme legislative. Riforme e conquiste sociali e operaie alle quali è corrisposta poi una controffensiva sia economico-sociale che politico-istituzionale che ne ha progressivamente neutralizzato forme e contenuti.
Soprattutto poi dagli anni novanta si è verificato in controtendenza un processo parallelo tra la trasformazione, dapprima strisciante e poi sempre più evidente, del rapporto tra impresa e lavoratori e fra Confindustria e Sindacati, da un lato, e tra governi, rappresentanza politica e sistema dei partiti dall’altro.
Il processo ritenuto tanto inevitabile quanto inarrestabile della “globalizzazione” alle cui regole e ai cui obbiettivi l’Unione Europea si è progressivamente allineata, ha comportato così - partendo dall’idea che i singoli stati nazionali non siano più in grado di governare da soli le scelte che la crescente complessità del mercato mondiale impone - un radicale mutamento non solo degli organi incaricati di reggere le sorti del nuovo sistema, ma anche dei nuovi strumenti sempre più accentrati in governi chiamati a rispondere alle continue sollecitazioni del mercato. Così, in un sistema a rete a maglie sempre più larghe, a vertici costituiti da organi come l’Organizzazione Mondiale del Commercio, Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale - e su un piano diverso le Agenzie di Rating - fanno riscontro le corrispondenti Istituzioni Comunitarie che impongono ai governi statali precise regole di comportamento di cui ignorano a priori l’impatto sociale!
Anche se non pochi tra i costituzionalisti italiani si rifiutano di parlare di governance perché di questa nuova formula politica mancherebbe ogni riferimento formale sia nell’ordinamento giuridico che nelle leggi che regolano il funzionamento delle istituzioni, la realtà appare ben diversa.
Innanzitutto perché la riforma dell’ art. 81 cost. (che ha affermato il principio del pareggio/equilibrio del bilancio) limita non poco le scelte di politica economica del governo e del parlamento dando legittimità e copertura istituzionale agli impegni comunitari assunti dal Paese con il MES, il TSCG e il Fiscal Compact; in secondo luogo perché molti dei poteri di regolazione e di gestione di attività e servizi di grande rilievo per l’economia del paese, e soprattutto per i diritti sociali ed i servizi pubblici, sono stati ceduti alle Autorità Amministrative Indipendenti, deresponsabilizzando in molti campi governo e parlamento; in terzo luogo perché l’ampio processo di privatizzazione di beni e servizi pubblici ha relegato al mercato ampi settori d’interesse nazionale e locale di forte impatto economico e sociale.
Con questa svolta di carattere tecnocratico-manageriale il sistema rappresentativo ha ceduto il passo a governi tecnici che non si preoccupano della loro legittimazione politica e sociale perché ritengono di dover rispondere delle loro scelte solo alle istituzione del Mercato sia a livello globale che europeo.
L’impegno dello S.L.A.I. - COBAS per un’assemblea generale da svolgersi a settembre per creare un fronte comune operai/lavoratori/intellettuali/stampa/mondo dell’istruzione e della formazione, per il NO alla Riforma della Costituzione, assume così un preciso significato economico e sociale che va ben al di là delle riflessioni normative ed istituzionali di altri attori che pure si oppongono a questa riforma.
Spacciata per riforma del Senato, la riforma della Costituzione sulla quale i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il loro voto, va letta innanzitutto assieme alla riforma della legge elettorale, l’Italicum, sulla quale, secondo tutte le previsioni, saranno chiamati ad esprimere il loro parere sia i cittadini che la Corte Costituzionale, dal momento che una risicata maggioranza parlamentare – senza dimenticare che è stata varata da un parlamento delegittimato dalla dichiarazione d’incostituzionalità del Porcellum – non ha tenuto conto alcuno delle considerazioni della Corte Costituzionale. Ne è scaturito un testo che in caso di ballottaggio rischia di attribuire la maggioranza dei seggi della Camera ad una formazione che abbia racimolato pochissimi voti e che magari sia risultata minoritaria nella prima tornata elettorale. Senza dimenticare più di un dubbio che suscita la nuova composizione del Senato innanzitutto per quanto riguarda il suo nuovo assetto che impone un preoccupante carico di lavoro doppio (ad esempio, senatore e presidente di regione.. ), reso per di più precario dalla dipendenza del Senato dalla stabilità politica ed istituzionale dei suoi membri. Ma i dubbi riguardano anche altri aspetti, come l’idea davvero peregrina di un Organo che elegge da solo e in totale autonomia ben due giudici costituzionali, con il rischio palese che prevalgano logiche di potere interne ed autoreferenziali. E ricordando ancora gli inevitabili conflitti Regioni/Stato, dovuti al deciso accentramento di poteri non solo legislativi che rischiano di ridurre l’autonomia regionale a ben poca cosa.
L’evidente parallelismo fra gli interventi del governo in materia di sciopero e di rappresentanza sindacale, di un governo che ha nella propria strategia il rifiuto di quel rapporto dialettico con le rappresentanze sindacali che in passa to ha caratterizzato e condizionato le politiche economiche sia nazionali che meridionali, e l’attuale processo di concentrazione di potere non solo esecutivo nel governo, induce a considerare la doppia riforma elettorale-costituzionale, per più versi intersecantesi, come la tappa finale di un disegno decisamente e coerentemente antidemocratico ed antisociale, destinato a stravolgere un sistema costituzionale modello esemplare per molte costituzioni del novecento e del nuovo millennio.
Le critiche rivolte alla revisione costituzionale sulla quale gli italiani dovranno esprimere il loro voto non sono frutto di partito preso; non si può infatti escludere per il futuro una revisione costituzionale che sottragga ad esempio ad un nuovo Senato il potere di concedere o negare la fiducia al governo. Ma una tale riforma andrebbe realizzata innanzitutto nel quadro di un progetto di riforma condiviso da una larga maggioranza dei partiti presenti in Parlamento e delle forze politiche e sociali del Paese; ed in secondo luogo disegnando con intelligenza ed acume i compiti e le funzioni di una seconda camera. Sembra infatti indispensabile un Senato che recuperi ed esprima in modo coerente ed equilibrato la rappresentanza di interessi, bisogni ed esigenze delle comunità locali. Una rappresentanza che, in una fase storica nella quale i processi di globalizzazione e di una integrazione europea a trazione monetaria/finanziaria e tecno-burocratica (nella quale i popoli non si riconoscono), dovrebbe tendere a controbilanciare quel processo di accentramento di poteri decisionali nel governo nazionale, che l’attuale revisione costituzionale invece accentua. L’attuale revisione costituzionale che interviene contemporaneamente e disorganicamente su ben quaranta articoli, toccando i sistemi elettorali di organi costituzionali quali il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale e complicando piuttosto che semplificare i procedimenti di formazione delle leggi e, ironia della sorte, attribuendo al nuovo senato il potere/dovere di controllare quello stesso governo a cui non è più legato da un rapporto di fiducia non ha convinto né gli studiosi né gran parte del mondo politico. Ciò rafforza il legittimo sospetto che una tale frettolosa riforma non sia stata meditata e proposta per rendere più efficienti e democratiche le nostre istituzioni fondamentali, ma sia piuttosto il frutto di una precisa volontà del governo in carica di rafforzare ulteriormente i propri poteri sia esecutivi che normativi, comprimendo decisamente i poteri e il ruolo del Parlamento.
*Già Professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Federico II di Napoli


1.gif)