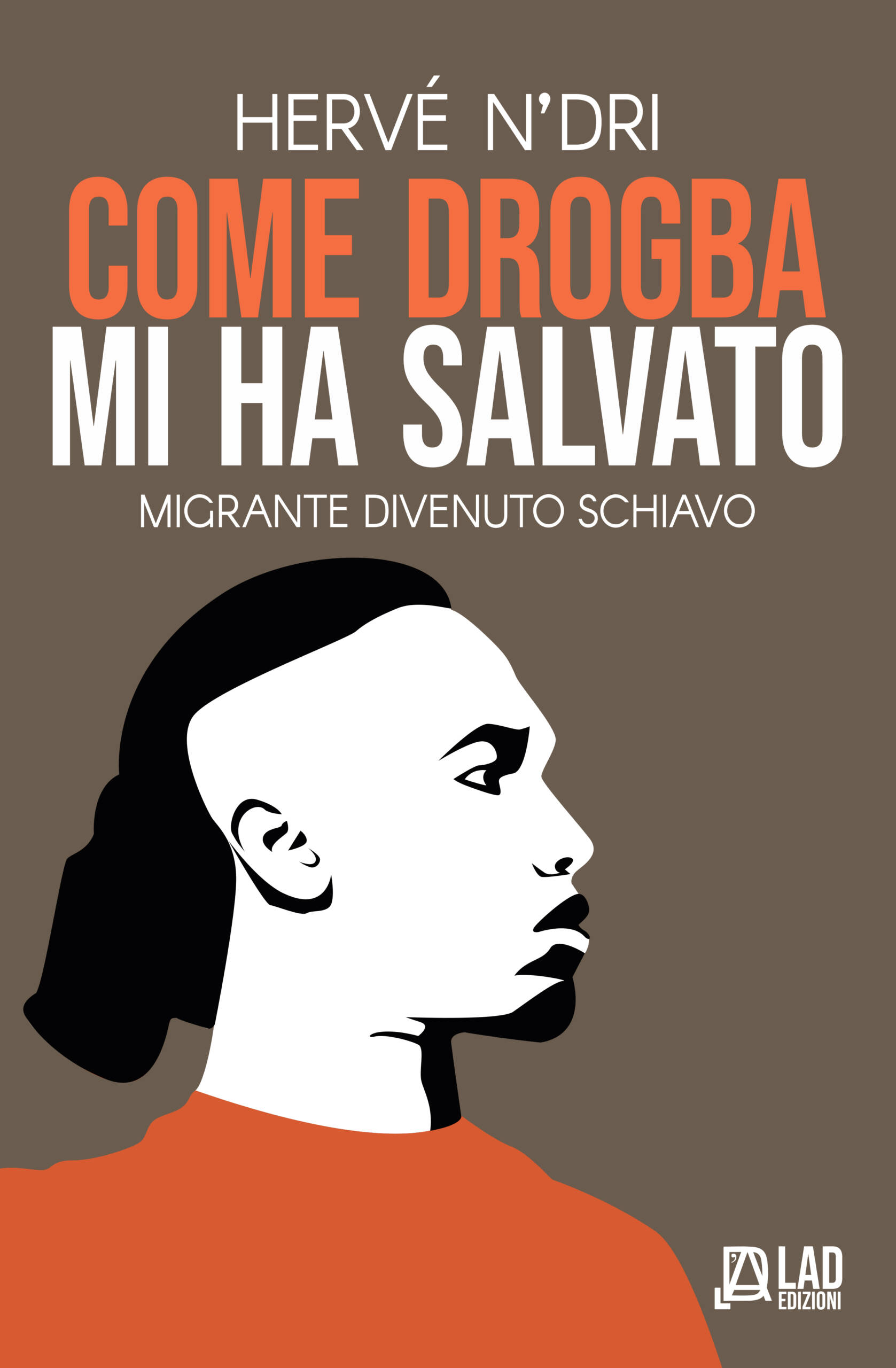I 14 punti di Eco sul "fascismo eterno" e l'occidente di oggi
di Leonardo Sinigaglia
Periodicamente, l’Occidente elegge un suo nemico al ruolo di novello Hitler, portando alle estreme conseguenze, quelle dell’equiparazione al “male assoluto” per definizione, il processo di “mostrificazione” di cui viene fatto oggetto qualunque personalità politica non disposta a piegarsi alla volontà dell’imperialismo statunitense.
L’ultimo in ordine temporale ad essere stato vittima di ciò è il presidente russo Vladimir Putin, più volte associato a Hitler in relazione sia a fantasiosi progetti di conquista dell’Europa a lui attribuiti, sia al regime totalitario che avrebbe costruito in Russia, sia a una generale predisposizione alla più sadica stravaganza, con bagni a base di sangue di cervo [1] e tritacarne donati in sfregio alle madri di soldati caduti in Ucraina [2].
Putin, in poche parole, sarebbe fascista in quanto incarnazione terrena di ogni vizio, di ogni malvagità possibile. Questa narrazione diffusa negli ambienti suprematisti occidentali non si basa solo sull’attribuzione propagandistica di ogni possibile crimine al proprio nemico, ma anche su di una definizione di “fascismo” che si riduce essenzialmente al piano morale, a una predisposizione di una persona (o di un sistema politico) a comportarsi in maniera ritenuta al di fuori dall’accettabilità civile: fascismo è quindi sinonimo di violenza, di prepotenza, di aggressività, di maleducazione, di irriverenza, di mancanza di inclusività e di discriminazione.
Una definizione che può far comodo ai giornalisti occidentali per tentare di mobilitare emotivamente il loro sempre più ridotto pubblico, ma che si dimostra assolutamente inutile per comprendere cosa sia stato il “fascismo” e cosa si possa definire “fascista”.
Questa visione moraleggiante e “metastorica” del fascismo si è diffusa in Italia e in tutto l’Occidente grazie agli sforzi culturali e ideologici dei liberali, in particolare dei liberal-progressisti, i quali hanno saputo monopolizzare il discorso sul fascimo e, pertanto, sull’antifascismo, eliminando ogni collegamento alla realtà materiale e storica per approdare a una costruzione infantile quanto assolutoria. Infantile perché pone in maniera estremamente semplificata e manichea un rapporto antinomico tra un fascismo-cattiveria e un antifascismo-bontà; assolutoria perché permette di rimuovere ogni responsabilità politica della borghesia liberale nell’ascesa e nella costruzione dei regimi fascisti, presentati come un corpo estraneo avventatosi improvvisamente sulla società.
Il “fascismo eterno” e la questione morale.
Questa ricostruzione del fascismo ha come massimo esponente Umberto Eco con la sua formulazione di “fascismo eterno”. L’omonimo intervento fatto da Eco alla Columbia University il 25 aprile del 1995 è la perfetta rappresentazione dell’ipocrisia e della vacuità dello sguardo liberale sul fascismo. Eco parte da un dato oggettivo, ossia la natura poliforme ed eterogenea delle esperienze “fasciste”, quella italiana tra tutte, per elaborare una serie di “tratti comuni” che individuerebbero un “fascismo eterno”, capace di manifestarsi, mutatis mutandis, in qualunque momento la società liberale dovesse abbassare la guardia. Vale la pena analizzare i quattordici punti individuati da Eco.
- Culto della tradizione: stando a Umberto Eco, la prima caratteristica del fascismo eterno sarebbe un tradizionalismo “sincretico”, dove più tradizioni sono accorpate, nonostante le loro contraddizioni, e viste come riflessi della stessa “rivelazione originaria” consegnata nell’Antichità all’umanità. Questa tendenza fu sicuramente riscontrabile tanto nel regime fascista italiano, che recuperò retoricamente e fuse la memoria della Roma pagana e mediterranea e della Roma cristiana ed europea, quanto nel neofascismo, per il quale il punto di riferimento più influente fu sicuramente il tradizionalismo evoliano, ma diventa ben più problematico associarla ad altre componenti della galassia fascista italiana o mondiale. Ben poco a che spartire con tutto ciò avrebbe la componente del Fascismo italiano influenzata dal Futurismo, movimento antitradizionale per eccellenza, e, sul versante opposto, difficilmente si potrebbe parlare di “tradizionalismo sincretico” in relazione a movimenti fascisti come quelli romeno, portoghese e spagnolo, dove la centralità del di un cristianesimo intransigente lasciava ben poco spazio a qualsiasi tipo di promiscuità.
- Rigetto della modernità, dello “spirito del 1789” e irrazionalismo: secondo Eco, l’esaltazione fatta dai regimi fascisti per l’industria e il progresso tecnico sarebbe solo “superficiale”, in quanto ricondotta a modelli ideologici che negherebbero i fondamenti politici e sociali della modernità. Servirebbe però ricordare come lo “spirito del 1789” abbia trovato tra i primi oppositori più radicali proprio i liberali che vedevano l’irruzione delle masse popolari nell’agone politico come una minaccia all’ordine e al diritto di proprietà. Burke, tra i più noti critici della Rivoluzione, vedrà nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo una teoria eversiva che apre la strada alle rivendicazioni politiche e sociali di "parrucchieri" e “candelai”, “per non dire di innumerevoli altre attività più servili di queste”, alle rivendicazioni della “moltitudine suina”, a gente la cui posizione sociale e il ruolo dipendente porta “una meschina prospettiva delle cose umane” [3]. Similmente si esprimeva qualche decennio dopo Jeremy Bentham, che definiva la Dichiarazione un insieme di “sofismi anarchici”, giudicando particolarmente assurdo il principio dell’eguaglianza, un qualcosa che può fare piacere solo alla “moltitudine ignorante” e ai “fanatici” [4]. Per i liberali lo “spirito del 1789” è stato molto problematico da accettare proprio perché pone in prospettiva il superamento dell’ordine socio-politico liberale, fondato su una rigida gerarchia che separa i colti, i competenti, i benestanti dalla massa ignorante e incapace di gestirsi, dalle “razze bambine” da sfruttare e controllare, da tutti quegli elementi della società ritenuti inadeguati a una piena fruizione dei diritti e delle prerogative della cittadinanza. Si potrebbe inoltre aggiungere come “l’irrazionalismo” in questione possa essere perfettamente contestualizzato nel clima culturale di un'epoca segnata da una lato dagli ultimi tentativi da parte della Chiesa cattolica di resistere all’accettazione del mondo moderno, dall’altro da una grande reazione positivista, influenzata da pensatori come Nietzsche e Bergson, dal Simbolismo, dallo spiritualismo e dalle pratiche occultiste.
- Antiintellettualismo, culto dell’azione: da esponente della casta intellettuale impegnata a giustificare e sostenere il suprematismo liberal-occidentale, Eco non può che sentirsi punto nel vivo dalle espressioni anti-intellettualismo che hanno accompagnato la retorica dei regimi e dei partiti fascisti. Ovviamente, anche il disprezzo per l’autorevole intellettualità sarebbe un segnale del “fascismo eterno”. Mosso dall’arroganza tipica degli intellettuali liberali, Eco non si rende conto che l’antiintellettualismo non è altro che una reazione (legittima) al divario tra classi dirigenti e classi subalterne, una reazione che il Fascismo ha recuperato in chiave “populistica” per alimentare la forza del suo tentativo di rappresentarsi come movimento politico “rivoluzionario”. Anche parlando del culto dell’azione difficilmente si può vedere un’originalità nella scelta estetica fascista: si tratta del recupero di elementi propri della tradizione culturale aristocratica, che ha sempre visto l’atto eroico come bello e nobile in sé, senza eccessive preoccupazioni riguardanti l’utilità o la razionalità di questo.
- La critica come tradimento: secondo Eco, un tratto distintivo del “fascismo eterno” sarebbe il rifiuto di ogni critica, vista come minaccia esistenziale per un sistema di credenze sincretico e disomogeneo. E’ bene però ricordare come la chiusura degli spazi del dibattito non sia un qualcosa di caratteristico unicamente dell’Italia tra il 1922 e il 1945 e della Germania tra il 1933 e il 1945, ma una tendenza che si manifesta qualsiasi sistema politico e sociale sottoposto a stress o colpito da una crisi. Difficilmente si potrà dire che la messa in discussione del modello liberal-capitalistico abbia conosciuto particolari libertà negli Stati Uniti della Guerra Fredda, cosi come non sembrano oggi particolarmente ampi gli spazi istituzionalmente riconosciuti per gli oppositori del progetto federale europeo e della moneta unica.
- Razzismo e paura della diversità: negli Stati Uniti, centro del liberalismo contemporaneo, le ultime “leggi razziali” vennero abrogate con il Civil Rights Act del 1964, varato quasi due decenni dopo dalla sconfitta dei regimi fascisti nella Seconda Guerra Mondiale e dopo decenni di attività terroristica contro gli afroamericani in nome della white supremacy. Nel Sudafrica, un altro Stato nato per gemmazione del liberalissimo Impero britannico, la legislazione razzista finì solo nel 1994, dopo anni di lotta armata, disobbedienza civile e pressioni internazionali. Il razzismo non è certo quindi un tratto unico dei regimi fascisti, che anzi furono influenzati da un clima culturale in cui la supremazia bianca, sostenuta dagli imperi liberali, godeva di grande popolarità. Nel Mein Kampf Adolf Hitler non solo mostra ammirazione per come le popolazioni statunitensi composte “per la maggior parte di elementi Tedeschi, che si mescolarono molto poco con le nazioni colorate inferiori” siano riuscite a dominare il continente proprio in virtù di questa purezza [5], ma uno dei principali teorici del pensiero razzista, Alfred Rosenberg, fu un ammiratore del massimo esponente della teoria suprematista bianca statunitense, Lothrop Stoddard, da cui mutuò l’approccio “scientifico” all’analisi dei rapporti tra le razze, unendolo all’arianesimo misticheggiante dell’inglese naturalizzato tedesco Houston Stewart Chamberlain. E’ necessario inoltre notare che la “paura del diverso” è proprio ciò che caratterizza maggiormente l’Occidente contemporaneo guidato dagli Stati Uniti. Con ciò non si vuole fare certo riferimento alla generica ostilità all’immigrazione di massa, ma al sentimento suprematista e gerarchizzante, volto a dividere il mondo tra un “giardino ordinato” occidentale e liberale e una “giungla” autocratica e barbara, di cui sono infarcite le classi dirigenti di Stati Uniti ed Europa. “L’altro” è visto non come portatore di una civiltà diversa ma dotata di una sua dignità, ma unicamente un inferiore da “civilizzare” ricostruendolo a immagine e somiglianza dell’Occidente o da eliminare tramite pressioni economiche, destabilizzazioni sociopolitiche e interventi militari.
- Frustrazione delle classi medie: Eco individua nel supporto delle classi medie preoccupate dalla crisi economica e sociale la principale forza del fascismo. Per quanto storicamente i movimenti fascisti abbiano raccolto il sostegno militante soprattutto da esponenti della piccola e media borghesia, Eco si dimentica come Hitler sia potuto salire al potere grazie al sostegno a lui dato dai ai vari Thyssen, Krupp, Kirdorf e Schacht in funzione anticomunista, non certo per merito di bottegai e artigiani. La demonizzazione della “frustrazione delle classi medie” viene portata avanti scientemente dall’intellettuale liberale in quanto risponde alla necessità di frazionare il campo degli sconfitti della globalizzazione americanocentrica, facendo pensare che il capitale finanziario, con la sua retorica cosmopolita e progressista, sia in qualche modo meno pericoloso delle classi medie in via di proletarizzazione.
- Ossessione per il complotto: per Eco l’identità nazionale necessita di un nemico permanente in opposizione al quale definirsi, e questo nemico è generalmente oscuro e dedito al complotto internazionale. È abbastanza ridicola la riduzione di un’identità nazionale, che si fonda tipicamente su di un passato plurisecolare e su di una memoria di questo condivisa, su di una comunità linguistica, culturale, economica e spirituale, a una semplice contrapposizione con “l’altro”, ma non sorprende: lo scopo dell’intellettuale liberale è ancora una volta la difesa degli interessi egemonici statunitensi. Se Eco nel suo testo evoca la paura per il “complotto giudaico-massonico”, diffusa nel secolo di certo non solo in ambienti fascisti ma presente trasversalmente nelle galassie anticomuniste tanto liberal-conservatrici quanto nell’intransigentismo cattolico, è chiaro come questa narrazione possa prestarsi alla demonizzazione di qualsiasi Stato costretto a vivere sotto l’eterna minaccia della guerra ibrida statunitense, o di qualsiasi movimento politico e sociale che si opponga alla volontà del capitale finanziario, facilmente accusabile di “complottismo” dai media liberali.
- Nemici esterni al contempo forti e minacciosi e deboli e destinati alla sconfitta: Eco evoca le sue memorie d’infanzia, quando la propaganda fascista dipingeva l’Italia “proletaria” e sobria in antitesi all’Inghilterra, ricca e decadente. Le “democrazie plutocratiche” erano quindi allo stesso tempo sia minacciose che destinate alla sconfitta, sia temibili che deboli. Un tratto caratteristico del fascismo? Parrebbe di no a ricordare quanto detto a reti unificate dai media liberali e dai politici occidentali sulla Federazione Russa a partire dall’inizio dell’Operazione Militare Speciale. La Russia sarebbe infatti al contempo un paese prossimo al tracollo, con un esercito debolissimo e un’economia devastata, incapace di vincere contro la minuscola Ucraina, e un paese sempre più minaccioso, pronto non solo a distruggere Kiev ma ad avanzare fino a Lisbona conquistando l’intera Europa, un paese che si arricchisce sempre di più grazie al commercio delle sue materie prime, contro cui nulla possono le sanzioni europee. Eco non è vissuto abbastanza per vedere il conflitto russo-ucraino, ma simili retoriche sono state utilizzate per definire l’Iraq di Saddam Hussein, la Libia di Gheddafi o, prima ancora, l’Unione Sovietica: paesi inferiori all’Occidente, ma allo stesso tempo terribilmente minacciosi.
- Guerra permanente, la pace è possibile solo dopo la vittoria finale: influenzati dal clima culturale già accennato, i movimenti e i regimi fascisti hanno messo al centro della propria visione del mondo l’idea dell’eternità dello scontro (delle nazioni, delle razze, di Dio contro il demonio…). Solo la vittoria finale di una delle due parti avrebbe portato alla fine di questa guerra, che quindi sarebbe stata da affrontare come permanente e connaturata alla stessa esistenza umana. Una prospettiva che appare pienamente comprensibile anche al giorno d’oggi, avendo vissuto l’Occidente in uno stato di guerra permanente e totale contro il resto del mondo almeno dalla fine della Guerra Fredda, una guerra che ha tutti i crismi dello “scontro di civiltà” e che si estende ben al di là del semplice elemento militare, una guerra che richiede una mobilitazione permanente per difendere “l’Occidente in pericolo” dal nemico esterno (i russi, i cinesi, i mussulmani…) e da quello interno (i putiniani, i “pacifinti”, i fiancheggiatori dei terroristi…), una guerra che potrà dirsi conclusa solo con la piena riduzione di tutto il mondo all’Occidente.
- Elitismo e disprezzo per gli inferiori: Eco riconosce l’elitismo con un pensiero aristocratico tipico di ogni “ideologia reazionaria”. Si dimentica però di ricordare come il liberalismo stesso sia nato come ideologia “elitista” contrapposto non solo all’assolutismo di un potere centrale privo di limiti, ma soprattutto contro la democrazia e il rischio “anarchico” connesso all’agitazione della plebe. Il liberalismo, riprendendo il discorso aristocratico classico già diffuso nel mondo antico, vede democrazia e dispotismo come intrinsecamente legati: la plebe non potrebbe che creare una realtà politica demagogica destinata a degenerare in tirannia. Il potere politico deve essere quindi appannaggio dei colti, dei benestanti, di chi, usando la ragione, riesce a guidare la società verso il bene senza farsi coinvolgere dalle passioni che agitano il popolo minuto. La “democrazia liberale”, nata solo una volta che lo spettro della rivoluzione socialista ha costretto le classi dirigenti borghesi ad unire la carota al bastone, si fonda sul medesimo schema, permettendo però un certo grado di coinvolgimento “mediato” delle masse. Questo coinvolgimento può essere diminuito all’occorrenza nei tempi di crisi, come mostra l’intollerabile retorica anti-populista degli intellettuali e dei politici liberali, che si spinge talvolta sino alla messa in discussione del suffragio universale e all’elogio aperto della tecnocrazia.
- Eroismo ed esaltazione della morte: la “bella morte” non è certo un’invenzione fascista, ma è un concetto che attraversa millenni di cultura latina, italiana e cristiana, e che trova le sue corrispondenze non solo nell’immaginario nazionalista degli altri paesi europei, ma, sostanzialmente, in qualsiasi civiltà, a tal proposito si pensi al ruolo centrale attribuito al martirio, accettato se non ricercato, nell’Islam sciita. Sarebbe inoltre abbastanza bizzarro mettere in rilevanza questo aspetto della retorica fascista come se si trattasse di un unicum, quando il periodo bellico contribuì enormemente alla diffusione di tali miti in maniera trasversale ai paesi e ai movimenti politici.
- Machismo: riprendendo le tesi già esposte nel 1933 dallo psichiatra anti-stalinista tedesco Wilhelm Reich, Eco collega la repressione sessuale al Fascismo, una narrazione da sempre cara agli ambienti liberali e libertari, poiché permette di mettere al centro dell’esperienza fascista l’individuo “patologico”, rimuovendone così ogni carattere politico e sociale. Eco arriva addirittura a vedere nella simbologia militare una “sostituzione fallica”. Interessante come l’Inghilterra vittoriana e liberale, con la sua cultura prude e sessuofobica, non sia però toccata dai ragionamenti su questa caratteristica del “fascismo eterno”.
- “Populismo selettivo”, ossia il Capo come interprete della volontà generale: nell’attacco al rapporto masse-dirigenza è pienamente visibile l’ostilità di Eco per le masse, per ogni sistema politico che vada al di là della liberale oligarchia dei “migliori” esercitata a beneficio di un “popolo bambino” da indirizzare e guidare. Criticando la negazione dei “diritti dell’individuo”, Eco esalta implicitamente la pretesa di pochi individui a gestire la cosa pubblica senza troppi riguardi per una pretesa “volontà generale”, derubricata a concetto populista, plebeo e, conseguentemente, tirannico.
- Utilizzo della “neolingua”: riprendendo il termine coniato dall’agente dei servizi segreti inglesi e militante anti-sovietico George Orwell, Eco afferma che un tratto distintivo del fascismo inteso in senso generale sarebbe la “neolingua”, un linguaggio semplificato finalizzato alla propaganda. Anche qui ci troviamo davanti a qualcosa di immediatamente comprensibile essendo ormai abituati da decenni alle “guerre umanitarie”, ai “malati sani” e al “riarmo per la pace”.
I quattordici punti esposti da Umberto Eco come caratteristiche del “fascismo eterno”, ossia tratti che contraddistinguerebbero in generale ogni esperienza fascista passata e futura, si dimostrano totalmente inadeguati a rappresentare specificatamente il fascismo per come storicamente si è manifestato, rappresentandolo in maniera distorta e propagandistica, ad uso e consumo degli ideologi liberali e dei regimi occidentali. Eco si ferma al dato esteriore, all’estetica, al turbamento della sua sensibilità morale progressista, e di conseguenza non può arrivare al vero tratto comune delle esperienze fasciste, che non è sicuramente la “paura del diverso” o il disprezzo per gli intellettuali, ma l’aver svolto la stessa funzione politica, aver espresso la stessa natura di classe. La diversità delle manifestazioni del fascismo si deve alla diversità delle condizioni nazionali e dei rapporti di classe in seno a ogni paese e nella posizione relativa del paese della divisione del lavoro internazionale.
Tale interpretazione moralistica del fascismo non è ovviamente un’esclusiva di Eco, ma ha le sue radici (involontarie) nella produzione intellettuale dei fratelli Rosselli e di Giustizia e Libertà. I due antifascisti videro nel movimento mussoliniano essenzialmente un male morale abbattutosi sull’Italia, frutto di elementi negativi da sempre caratterizzanti la nostra vita nazionale. Sebbene i caratteri economici e politici non rimanessero ignoti, l’elemento morale era quello centrale, tale concezione idealista non poteva però cogliere la reale natura dei processi politici in corso. I fratelli Rosselli furono indubbiamente dei patrioti italiani e dei martiri nella lotta contro il Fascismo, ma non seppero dare un contributo teorico completamente valido per condurre questo scontro. Un contributo del genere venne dato solo dall’Internazionale Comunista.
La definizione di Fascismo data dal Comintern.
La definizione di fascismo elaborata dall’Internazionale Comunista non si riduce a una descrizione del sistema costruito in Italia a seguito della Marcia su Roma o in Germania dopo la salita al potere di Adolf Hitler, ma risponde alla necessità di definire gli aspetti sostanziali di un processo politico che si vedeva in atto in tutto il mondo capitalistico, al di là della permanenza di elementi di parlamentarismo e di pluralismo politico. Il fatto che questo processo abbia avuto una prima stabile manifestazione in Italia con il movimento mussoliniano ha fatto in modo che si utilizzasse il termine “fascismo” per identificarlo, ma ciò non significa che “fascismo”, nel senso utilizzato dall’Internazionale comunista, sia sinonimo esclusivo del regime mussoliniano, o che in questo stesso regime abbia mostrato solo e soltanto i tratti caratteristici messi in rilevanza al VII Congresso del Comintern.
Nel corso del VII Congresso dell’Internazionale Comunista, svoltosi a Mosca nel 1935, Georgi Dimitrov, allora Segretario Generale del Comitato Esecutivo del Comintern e futuro Presidente del Consiglio della Repubblica Popolare Bulgara, tenne un’importante relazione sul fascismo. Questa prendeva in esame la comparsa dei movimenti fascisti nel contesto di un sistema capitalista entrato in profonda crisi a seguito del ‘29, travolto sia dalla competizione interimperialista che dal crescente malcontento delle masse. Davanti al rischio rivoluzionario e alla necessità di aumentare tanto la repressione interna quanto l’aggressività esterna, il capitale finanziario si servì di misure o movimenti “fascisti” per imporre sulla società uno stato d’assedio anti-comunista e anti-popolare, per aumentare il saccheggio delle ricchezze nazionali a suo vantaggio e per mobilitare le risorse del paese verso l’espansione imperialista. Il peso dei debiti della Germania verso i paesi dell’Intesa e di questi verso gli USA, unito agli squilibri economici venutisi a creare con la Grande Guerra e i successivi trattati, influenzarono profondamente la situazione, rendendo ancor più necessario per il grande capitale imporre misure di spoliazione e di repressione.
I movimenti “fascisti”, al di là degli elementi retoricamente populistici e patriottici, delle varie declinazioni identitarie e dall’estetica impiegata, furono lo strumento con cui tale progetto fu portato avanti nei paesi sì sviluppati dal punto di vista capitalistico, ma istituzionalmente e socialmente più deboli e sconvolti. Non è un caso che il fascismo emerse in Italia, paese in cui il capitale finanziario era nato all’ombra di quello straniero e che coltivava, più che veri e propri progetti, sogni imperialisti, e nella Germania, paese uscito sconfitto dal conflitto e devastato dai trattati di pace.
Dimitrov definisce il fascismo al potere come “dittatura terroristica aperta degli elementi più reazionari, più sciovinisti e più imperialisti del capitale finanziario”, e i movimenti fascisti, in primis quello tedesco, come “repart[i] di assalto della controrivoluzione internazionale” contro l’Unione Sovietica [6]. Questa definizione di fascismo risponde al suo carattere reale, alla sua dimensione concreta. Non perde tempo con analisi estetiche, voli pindarici sulla sessualità repressa o commenti sdegnosi sulle masse, ma mette al centro la funzione reale dei movimenti e dei regimi fascisti nel contesto reale in cui si sono sviluppati. Essa è quindi estremamente più efficace di quella liberale, e ancora oggi può essere un utile strumento nell’analisi politica.
Chi è oggi fascista? L’antifascismo serve a qualcosa?
Data questa definizione è chiaro che per stabilire chi oggi sia “fascista” ha poco senso interrogarsi sul machismo, sull’omofobia o sul complottismo. Serve interrogarsi su chi oggi possa ricoprire il ruolo rivestito nel Secolo scorso dai movimenti e dai regimi fascisti. Il sistema capitalista, evolutosi dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi in un sostanziale monopolio internazionale guidato dagli Stati Uniti che, grazie alla dittatura del dollaro e al ricatto militare, sono riusciti a soggiogare ogni “polo” capitalista alternativo, ha conosciuto crisi sempre più frequenti e devastanti, ed è sconvolto oggi dalla minaccia rappresentata dalle forze che si contrappongono al regime egemonico di Washington, in primis dalla Repubblica Popolare Cinese, un grande paese socialista economicamente ben più forte e sviluppato di quanto lo fu, in relazione ai tempi, l’Unione Sovietica.
Applicando la definizione data da Dimitrov possiamo quindi dire che i “fascisti” oggi sono i “reparti d’assalto” che il capitale finanziario schiera per garantire che la ricchezza nazionale venga saccheggiata impunemente e che l’ordine egemonico unipolare possa resistere. Ciò può assumere quindi forme diverse: “fascista” è il golpe bianco che esautora un presidente sudamericano poco incline alla sottomissione agli yankee; “fascista” è il reparto militare ucraino creato e armato per fare la guerra alla Russia per conto della NATO; “fascista” è il politico liberale che parla in televisione a sostegno dell’Unione Europea e contro l’indipendenza nazionale; “fascista” è il militante “antifa” che diffonde propaganda anti-russa, anti-iraniana e anti-cinese; “fascista” è il Segretario della CGIL che scende in piazza a favore del riarmo europeo, sotto le bandiere blu di Bruxelles. E questi sono solo alcuni esempi tra i numerosi che si potrebbero fare.
Esistono tre diversi tipi di “antifascismo”.
Il primo è quello “estetico”, tipico della galassia antagonista, che vede nel fascismo essenzialmente una manifestazione esteriore, un insieme di comportamenti o di simboli da combattere con fanatismo isterico. Ma non basta il busto di Mussolini in casa, la citazione del Duce caricata su Facebook o il commento sgradevole sui rom a far di qualcuno un fascista: essere fascisti non è una questione estetica, di gusti o di opinioni sgradevoli. Questo “antifascismo” nei fatti non solo è inutile, ma è controproducente, perché crea una versione macchiettistica tanto del fascismo quanto dell’opposizione ad esso.
Il secondo è quello legato alla memoria storica, e significa portare avanti il ricordo della Guerra di Liberazione Antifascista combattuta in Italia e, più in generale, della lotta condotta dai partigiani e dagli eserciti di tutto il mondo contro i regimi fascisti. Questo antifascismo fa parte dell’identità nazionale italiana e deve essere promosso e sostenuto, ma non deve essere confuso per l’opposizione militante a un regime non più esistente da quasi un secolo.
Vi è infine un antifascismo “sostanziale”, per cui, nel solco della tradizione comunista, essere antifascista significa opporsi al fascismo per ciò che realmente è, significa opporsi alla “dittatura terroristica aperta” che gli USA esercitano a livello internazionale, significa combattere i “reparti d’assalto” del capitale finanziario negando loro ogni solidarietà o vicinanza; significa sostenere l’avvento di un mondo multipolare e di una Comunità umana dal futuro condiviso.
Questo antifascismo è l’unico che, politicamente, ha senso portare avanti ai giorni nostri e che permette di portare avanti la causa dell’emancipazione nazionale, del popolo lavoratore e dell’intera umanità.
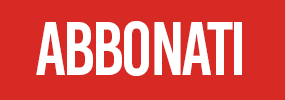

1.gif)