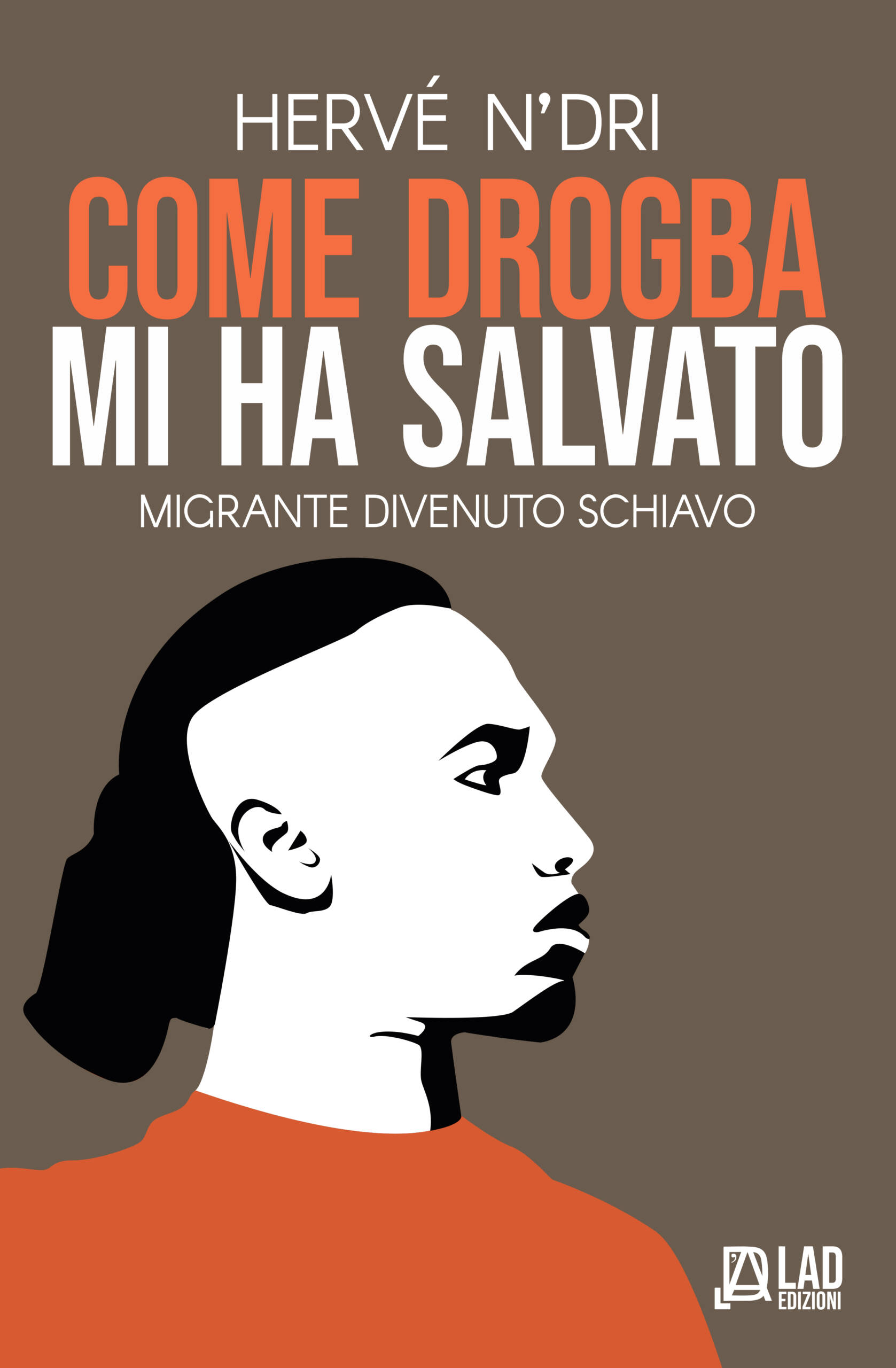La bussola del Covid
1732
Scrive il prof. Vincenzo Costa in uno dei suoi ultimi post su FB che “una discussione su quanto accaduto nel periodo pandemico sarebbe necessaria”. Detto questo però, “forse non si sapeva bene che cosa si stava affrontando, come affrontarlo”.
Per concludere che “quando però la questione del "siero genico" diventa un criterio di giudizio universale su ogni fatto della storia, su tutto ciò che accade, una sorta di soglia tra un prima e un dopo nella storia, (…) allora ogni discussione diventa inutile”.
Quando scoppiò ufficialmente la pandemia, nel febbraio 2020, mi accingevo a entrare in studio per montare il film “L’Urlo”, dacché le riprese erano terminate qualche settimana prima. Al termine di una ricerca che ormai durava già da 2 anni, sentii che l’immagine dell’Urlo poteva essere la sola a descrivere il mio punto di vista su tutto quanto visto e trovato fin lì. Da una parte una montagna di testimonianze dirette raccolte, inoppugnabili; dall’altra un’accoglienza nei confronti della mia ricerca che è passata dal suscitare stupore, poi interesse, infine terrore tra i miei interlocutori.
In quei due anni mi ero a lungo interrogato su cosa potesse ottenebrare le menti di fronte alle parole inequivocabili, perentorie e definitive dei migranti-schiavi in Libia che attraverso la mia ricerca si sono espressi. Non ci ho dormito le notti. Per due lunghi anni.
Alla fine, quando mi sono stati perfino offerti soldi per eliminare i passaggi più problematici di quelle testimonianze e, al mio rifiuto, tutti sono definitivamente scappati, ho cominciato a capire.
Non è che i miei interlocutori fossero stupidi o incapaci di comprendere il significato di quei messaggi o che i soldi piacessero solo a loro. E’ che il dare prova di aver capito quei messaggi e pertanto il sostenere questa ricerca, li poneva al di fuori del perimetro socialmente accettabile.
In altre parole non era in gioco la comprensione del messaggio di quei messaggi, non era in gioco nemmeno la propria idea sulla migrazione, era in gioco quel che gli altri avrebbero pensato di loro (e in definitiva la fortuna della propria traiettoria sociale).
E’ così che grappoli di sostenitori, ad un certo punto, certamente prima che le riprese fossero finite, come d’incanto sparirono, dopo aver annusato l’aria che tirava. Questa circostanza mi provocò molto sgomento. Ed è per questo che ho dato nome “L’Urlo” a quel lavoro.
Chissà, pensavo, se almeno un urlo riesce a far capire a queste persone che una cosa è vera quando è vera, non quando ti assicura i comfort e gli agi del gruppo di appartenenza. Dal mio punto di vista, continuare a sostenere le narrazioni fiabesche sulla migrazione dopo aver ascoltato quelle testimonianze dirette, era il sintomo del crollo strutturale di una civiltà, non più basata sulla ricerca del vero, ma sulla ricerca del punto di caduta del consenso conformizzato.
Il prof. Costa sostiene che “forse non si sapeva bene che cosa si stava affrontando, come affrontarlo”. Io, sin dai primi giorni di pandemia provai una noia profonda, esistenziale, soffocante. Pensavo innanzi tutto ai mesi che avrei perso a quel punto per chiudere questo benedetto film, ostacolato da tutte le parti e in tutti i modi, prima, durante e dopo la sua realizzazione.
Non mi serviva essere medico o scienziato per capire cosa stesse succedendo.
Non mi serviva la Scienza per descrivere un fenomeno che con la Scienza non aveva nulla a che fare. C’era un totem, issato sul piedistallo, così come fatto per la migrazione. E poi c’erano persone ormai prive di spirito critico che, nel dubbio, hanno per prima cosa pensato a come collocarsi per non trovarsi fuori da quel perimetro del socialmente accettabile. Quelle dinamiche le andavo studiando da anni, quotidianamente a disposizione sotto i miei occhi. In seguito alla pandemia c’è stato il Risveglio.
Moltissime persone da quel momento in poi hanno capito la differenza tra “professione della verità” e “giusta collocazione sociale” (cose che quasi mai coincidono). Molte di loro hanno pensato che la seconda non dispiace a nessuno, ma non al prezzo di far fuori la prima.
E’ questo un criterio di giudizio? Io temo di sì. E’ un paradigma. Che si può applicare in tutte le epoche e in tutti i contesti.
A cominciare dai tratti della “Parrhesia” socratica, che espone alla punizione o all’esclusione sociale colui che professa la “Verità” di fronte al Potere coercitivo di chi impone qualcosa non perché sia vera, appunto, ma perché sia conveniente al Potere stesso.
E’ una vecchia storia, vecchia quasi quanto l’Umanità.
La pandemia Covid19 (o come diavolo si chiama) ha solo rinfrescato la memoria all’umanità che aveva forse smarrito questo insegnamento. Coloro che si sono vaccinati sono dunque tutte cattive persone e stupide? No, non necessariamente.
Hanno tutte accettato il vaccino per non essere socialmente escluse e per non perdere i privilegi acquisiti in società? No, non necessariamente.
Tutti coloro che non si sono vaccinati sono ormai persone esenti dalle trappole e dalle insidie della manipolazione di massa corrente? No, non necessariamente. Ma non ho nulla da biasimare a chi oggi, per districarsi nella tossicità moderna del reale, utilizza quella pagina storica per orientarsi. E' già qualcosa.
Ognuno utilizza le proprie bussole.
La mia me la sono fabbricata durante le riprese dell’Urlo, quando la pandemia era ancora lontana nel tempo, per esempio.
E da allora in poi ad adorare i totem ho trovato quasi sempre le stesse persone, che fosse la pandemia o la migrazione o la guerra in Ucraina (Gaza è argomento complesso).
Seguendo la quale bussola personale, non ho assistito a miglioramenti sul piano dell’accettazione sociale dei testi che vado scrivendo da allora, ma non mi sono trovato nemmeno gambe all’aria di punto in bianco.
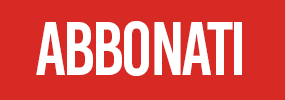

1.gif)