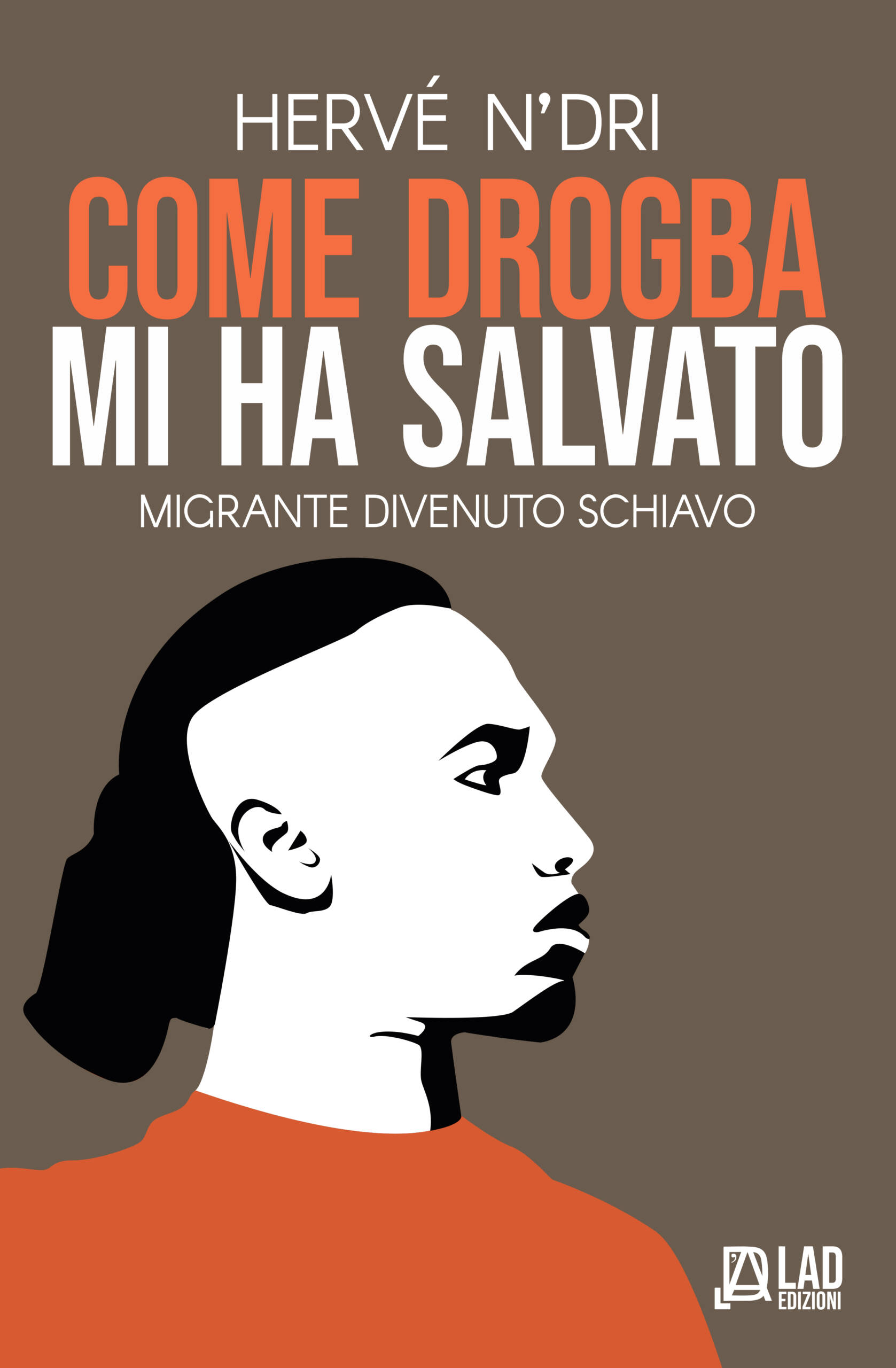LA CREATIVITA' RIDOTTA A MECCANISMO DELLA COSTRIZIONE: UN VIAGGIO FILOSOFICO-LETTERARIO
di Diego Angelo Bertozzi*
Come i nostri lettori sanno l'AntiDiplomatico è anche una casa editrice impegnata su diversi fronti culturali (dalla politica estera, all'immigrazione fino ai romanzi) e si distingue da gran parte del panorama editoriale italiano di piccole dimensioni per il rifiuto della pubblicazione a pagamento. Una scelta editoriale non solo all'insegna della serietà, ma anche fortemente politica, perché in opposizione all'onnipervasivo, quando non totalitario, dominio del modello liberistico che ha ridotto persino la creatività a riproduzione del sempre uguale, a obbediente ancella del consumo. In questo, chi scrive, riprende le riflessioni del filosofo tedesco Byung-Chul Han contenute nella sua opera "Contro la società dell'angoscia. Speranza e rivoluzione" (2023). Pubblicità, corsi di formazione, programmi televisivi sono gli odierni spacciatori di una creatività come soluzione per la riuscita nella propria vita professionale. In astratto potrebbe anche essere vero, ma resta il fatto che essa è indissolubilmente legata alla libertà; ad una libertà tale che, per il nostro autore, evoca "qualcosa di radicalmente Altro, qualcosa di nuovo e inaudito". Ma la realtà concreta che viviamo è quella di un regime neoliberale produttore di angoscia, che isola tra loro le persone rendendole imprenditori di se stessi, imprimendo alle loro vite la "costrizione a essere performanti" in un contesto di perenne concorrenza. Tale costrizione alla performance è una privazione della libertà: "ci sottomettiamo liberamente alla costrizione di essere creativi, prestanti, di essere autentici". Ed è così, che in un clima di angoscia sempre più diffuso perché privo di reali e vissuti legami, la creatività viene posta all'esclusivo incremento della produttivà, senza poter mai immaginarne una fuoriuscita. Resta bloccata, senza tempo, nella ripetizione di una forma di vita che è quella della produzione e del consumo.
Prima ancora del filosofo tedesco, sempre in ambito editoriale, il poeta Leopardi aveva colto come la produzione letteraria stesse scivolando lungo il piano inclinato della produzione e di un consumo superficiale, alla moda. Così si esprimeva: "La sapienza economica di questo secolo si può misurare dal corso che hanno le edizioni che chiamano compatte, dove è poco il consumo della carta e infinito quello della vista. Sebbene in difesa del risparmio della carta nei libri, si può allegare che l'usanza del secolo è che si stampi molto e che nulla si legga"; e le novità introdotte nei caratteri di stampa danno certo maggior lustro alla carta e sono "ben ragionevoli in un periodo nel quale i libri si stampano per vedere e non per leggere". (Pensieri, III)
Mezzo secolo dopo di lui, nel racconto distopico "La fine dei libri" scritto nel 1896 - ma per molti versi percorritore dei tempi attuali - il colto ed eclettico Octave Uzanne tratteggia con sagacia e ironia il possibile sviluppo di un'editoria nella quale il contenuto è sovrastato dalla confezione, il narrato dalla prestazione del narratore. A fine Ottocento immagina la diffusione di fonografi "che siano insieme portatili, leggeri e resistenti tanto da registrare senza guastarsi i lunghi romanzi che al giorno d'oggi hanno quattro, cinquecento pagine [...]"; piccoli cilindri leggeri come portapenne tanto da potersi tenere in una tasca. Si potrebbe trarre una immediata conclusione: aumenterebbe così la circolazione di testi e la lettura diverrebbe fenomeno ancor più popolare, facendo propri anche gli interstizi di tempo di tutta una giornata. Tutt'altro: il racconto, il contenuto sarebbe sopraffatto dal mezzo - oltre al fatto che aumenterebbe esponenzialmente l'auto pubblicazione e l'autore diverrebbe il promotore di se stesso - e la lettura dall'abilità tecnica. Come enfaticamente sottolinea Uzanne gli "uomini di lettere non saranno più scrittori, ma piuttosto narratori" e "l'arte della dizione acquisterà proporzioni impensabili; esisteranno narratori ricercatissimi per la loro abilità, la comunicativa, il calore vibrante ...". Ad avere il sopravvento sarà la "prestazione" in un mercato nel quale si imporrà, non più lo scrittore, ma la tecnica di chi ne leggerà le parole. Così gli autori "privi di sensibilità per le modulazioni della voce e senza le inflessioni necessarie a una buona dizione, ricorreranno ad attori o cantanti stipendiati per incidere le loro opere sui compiacenti cilindri". La spietata concorrenza del mercato.
Ed eccoci tornare, nuovamente, alla centralità della performance, alla necessità di trovare a ogni costo la via per essere performanti. Sono riflessioni, queste, che possiamo trovare anche in Walter Benjiamin, il filosofo tedesco, autore, tra gli altri, del saggio "L'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica" (1935-36) quando analizza il fenomeno del culto delle star per collegarlo alla crisi della democrazia perché ad imporsi è il meccanismo della "selezione" come in una gara sportiva: il politico, come l'attore, interpreta se stesso, deve acquisire la tecnica migliore per prevalere di fronte al pubblico; una selezione che "avviene di fronte all'apparecchiatura, dalla quale escono vincitori il campione, la star e il dittatore". La necessità di emergere in un perverso e onnipresente meccanismo, nel momento stesso in cui loda il genio o la creatività, li irretisce nel nome della produzione, della corsa al successo e al compiacimento; è la creatività di chi deve fin da subito pensare il sempre uguale se vuole emergere. Per quanto illuminata dalla fantasmagoria delle luci e delle vetrine, resta una traccia tra le tante tracce di un medesimo e sempre battuto percorso. La creatività non è più ostetrica di un mondo altro, ma uno sterile ingranaggio del già-visto.
*Curatore della collana "Scaffale orientale" di LAD Edizioni
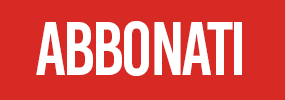

1.gif)