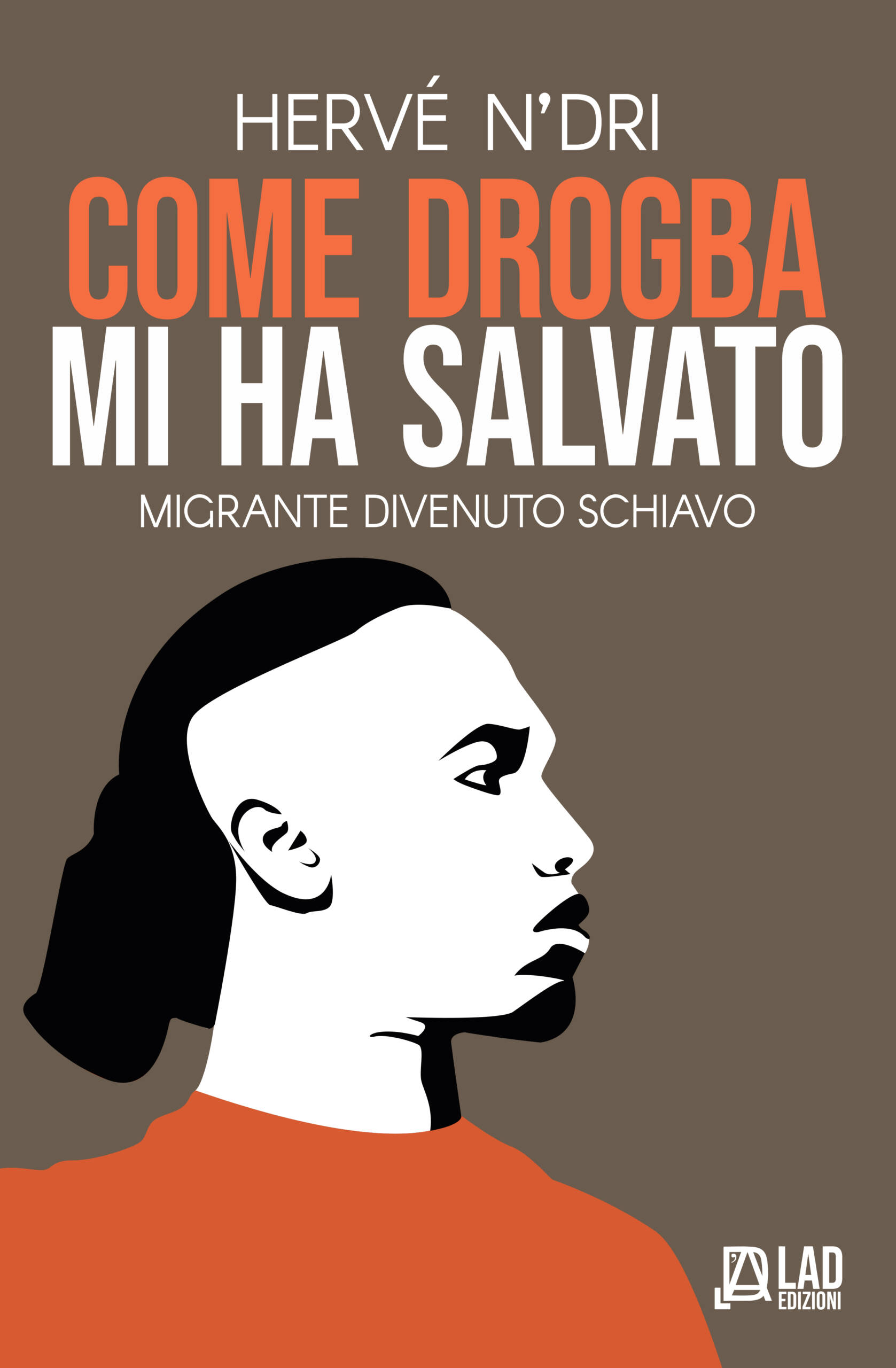La guerra imperialista dei dazi
Il protezionismo come prassi storica del capitalismo e base materiale del neoprotezionismo di Trump. La consustanzialità dell’isolazionismo alla guerra imperialista e all’odierna spinta bellica degli Usa. La necessità delle lotte dei comunisti e dei popoli per la liberazione dal giogo imperialista e della Nato
di Fosco Giannini
Non saranno forse, “i dieci giorni che sconvolgeranno il mondo”, ma certo la quindicina di giorni che ha separato la seconda investitura di Trump alla Casa Bianca (20 gennaio 2025) dalla firma, da parte dello stesso presidente Usa (4 febbraio 2025), dell’ordine esecutivo per l’avvio della guerra doganale, ha già scatenato una scossa tellurica, sul terreno economico-finanziario internazionale, di almeno 9 gradi della scala Mercalli.
Il neo-protezionismo “trumpiano” inizia ufficializzando nuove tariffe doganali del 25% contro Messico e Canada e del 10% contro la Cina, che si assommerebbero, se praticate, a quelle già in atto contro il gigante guidato dal partito comunista cinese. Inoltre, “per proteggere gli Usa” anticipatamente da ogni ritorsione, il provvedimento firmato da Trump prevede “una clausola di ritorsione” in grado di far innalzare le stesse barriere doganali contro i Paesi già colpiti, qualora essi rispondessero con uguali misure protezionistiche.
Consapevole dell’atto di guerra economico-finanziario proclamato e della sua gravità oggettiva, Trump ha inoltre ratificato, ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, “lo stato di emergenza nazionale”, che gli consentirebbe di disporre di ampi poteri per affrontare le eventuali e molto probabili crisi e contraddizioni, sia sul piano internazionale che su quello nazionale. Uno “stato di emergenza” che evoca sia l’aggravamento delle tensioni internazionali, sino alle guerre (che l’intera e ormai lunga storia dell’isolazionismo imperialista e capitalista ha dimostrato avere in sé come le nubi la pioggia), che un oscuro “giro di vite” sulla democrazia interna nordamericana, l’accentuarsi della lotta di classe padronale contro l’intero mondo del lavoro e del disagio sociale di massa e il ritorno delle politiche razziste e socialmente discriminatorie negli Usa, tutto ciò ampiamente verificatosi nell’altra e storica esperienza isolazionista nordamericana degli anni ’20 e in altre esperienze protezioniste della storia capitalista, a cominciare dalla fase dell’ “autarchia” fascista italiana, lanciata da Mussolini dopo, e in ritorsione, alle sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Italia, successive all’invasione imperialista fascista dell’Abissinia del 1935.
Il fatto che all’indomani della dichiarazione di guerra commerciale a Messico, Canada e Cina, e dopo la giornata di tempesta per le Borse mondiali Trump abbia concesso (5 febbraio) il rinvio di un mese dell’entrata in vigore delle nuove tariffe del 25% a Messico e Canada per consentire ulteriori trattative, non cambia la sostanza delle cose: l’impulso dell’Amministrazione Trump ad un nuovo protezionismo rimane totalmente in campo ed esso, consustanziale alla spinta statunitense al conflitto militare, può segnare l’intera fase mondiale.
Le misure protezionistiche di Trump contro Messico, Canada e Cina (rinviate, ribadiamo, di un solo mese per Messico e Canada) sarebbero dovute scattare il prossimo 18 febbraio e avrebbero riguardato, oltre a quelle già elencate nel primo attacco del 4 febbraio (soprattutto auto e prodotti dell’agricoltura) una vasta area di altre merci, tra le quali gas, petrolio, micro chip, medicinali, acciaio, alluminio e rame.
“Abbastanza presto toccherà all’Europa”, ha “promesso” Trump lo scorso 4 febbraio, nella conferenza stampa di presentazione, a Capitol Hill, del decreto “nuovi dazi”. “I Paesi dell’Ue - ha ribadito il presidente Usa - si rifiutano di aprire significativamente i loro mercati alle nostre automobili, ai nostri elettrodomestici, ai nostri prodotti farmaceutici, alla nostra agricoltura. E così proseguendo meriteranno le altissime tasse che applicheremo sulle loro merci, che invece invadono i mercati americani”.
Le risposte alla guerra doganale “trumpista”, lo stesso 4 febbraio, non si sono fatte attendere: il premier canadese Justine Trudeau si è rivolto duramente contro Trump affermando che il Canada avrebbe reagito ai dazi statunitensi sulla base (una determinata minaccia economica, questa) del “dollaro per dollaro”. Chrystia Freeland, già ministra del Commercio estero e con tutta probabilità nuovo primo ministro canadese al posto dello stesso Trudeau, ha anticipato una propria linea ferrigna e disinvoltamente ostile alla guerra doganale di Trump, chiedendo sin da subito al governo di Ottawa, prima della svolta di Trump volta a concedere una breve fase di trattativa, di applicare “forti dazi sull’importazione di Tesla”, per colpire direttamente Elon Musk, sodale del presidente Usa e suo “compare di merende”.
L’Ue, in relazione diretta alla propria fatiscenza di soggetto privo di fondamenta storiche e invenzione spuria del grande capitale transnazionale, ha risposto alle minacce di Trump (non ancora ben definite e basculanti tra una punizione tariffaria del 10% uguale per tutti i Paesi Ue a punizioni differenziate) in modi diversi ma tutti subordinati: dall’apparente durezza subito mitigata dalla subordinazione della premier danese Mette Frederiksen, (“Abbiamo bisogno di una risposta collettiva e robusta, perché ora dobbiamo davvero aumentare e accelerare lo sforzo per la difesa, in quanto la Russia e Putin non minacciano solo l'Ucraina, ma tutti noi e dobbiamo essere in grado di difenderci, quindi far funzionare le linee di produzione - delle filiere militari europee, n.d.r.- più velocemente”), al nuovo inchino a Trump della Meloni (“Meglio evitare il muro contro muro, non avere reazioni scomposte e cercare, come ha fatto il Messico, di negoziare”), sino al vago progetto evocato da alcuni membri del Consiglio europeo secondo i quali si starebbe costituendo un “gabinetto” della von der Leyen volto a delineare un risposta alla guerra dei dazi.
La presidente messicana Claudia Sheinbaum, dopo essersi consultata con Trudeau e stabilito un primo asse canadese-messicano volto a “rafforzare le già importanti relazioni bilaterali”, ha annunciato, anch’essa prima della decisione americana di riaprire per un mese la discussione sui dazi e sul traffico di uomini e merci alle frontiere tra Messico e Usa, che il Messico avrebbe tassato significativamente, a sua volta, le importazioni americane, puntando a concordare con Ottawa un coordinamento tariffario diretto a controbilanciare, con energia, l’attacco americano.
Severa è stata la risposta di Pechino: una nota del Ministero del Commercio del 3 febbraio aveva assicurato che “le misure cinesi saranno corrispondenti all’imposizione americana di tariffe del 10%” ed il “Global Times”, testata che fa capo al “Quotidiano del Popolo”, organo del partito comunista cinese, aveva affermato, in modo tanto controllato quanto determinato, che “le misure di Trump si ritorceranno innanzitutto sui consumatori americani, e che la Cina è un Paese resiliente e ha avuto tutto il tempo per mettere in atto misure preventive volte ad evitare il contraccolpo a cui punta la guerra doganale di Trump”. Decisioni, queste di Pechino, che il 5 febbraio si sono ulteriormente inasprite, con l’annuncio un rialzo sino al 15% di tassazione su diverse merci americane dirette al mercato cinese.
Due concezioni, tra loro agli antipodi, si affrontano, come riflessi dell’antico dibattito interno al mondo capitalista e tra gli stessi economisti liberali divisi tra filo e anti protezionisti, già in questi giorni surriscaldati: da una parte Trump, che afferma come l’innalzamento delle tassazioni sulle merci di importazione “trasformerà gli Usa in una nazione florida, che i dazi renderanno gli Usa molto ricchi e potenti”. Per Trump “il protezionismo è uno strumento per ridurre il deficit commerciale, rafforzare l’industria manifatturiera domestica e aumentare le entrate del governo”. E sul rischio inflazione afferma che “i dazi non causano inflazione, ma portano successo”. D’altra parte le posizioni di coloro che interpretano le “misure Trump” non solo come spinte dirette all’acutizzazione delle contraddizioni internazionali (in una fase già contrassegnata dalla pulsione oggettiva, da parte dell’asse anglo-americano, ad una terza guerra mondiale “risolutiva” dell’angosciante, per questo fronte, cambiamento di rapporti di forza internazionali a sfavore dell’imperialismo), ma anche come scelte devastanti per la stessa economia americana, come basi per la restrizione del mercato interno e l’allargamento del già grande, di massa, disagio sociale americano. Ed è su questa posizione critica Ian Brenner, direttore di Eurasia, thin thank globale: “Con la Trumpnomics stiamo entrando in un periodo di grande incertezza e potenziale instabilità. Nessuno sa che cosa vuole davvero il presidente; si dice stia lanciando dazi elevati perché, da dealmaker, vorrebbe usarli come base di trattativa. Ma i negoziatori di Canada e Messico sostengono di non riuscire a capire le vere intenzioni di Trump: è nello stato d’animo ‘prima spara e poi fai domande’: così è difficile fare un’analisi. Anche perché, poi, magari ci ripensa e rimette la pistola nella fondina (e la concessione, da parte di Trump, del mese di trattativa a Canada e Messico dopo l’annuncio di guerra dei dazi del 4 febbraio, sembrerebbe corroborare questa tesi, n.d.r.). Il Messico dipende molto dall’export verso gli Usa, vero. Ma ci sono problemi anche per gli Usa. Alcune imprese americane sono ormai piuttosto integrate con i fornitori messicani. E poi, il rischio inflazione. Trump dice di non temere fiammate dei prezzi, che in verità non vi furono nemmeno dopo i dazi del suo primo mandato. Ma quello era un periodo di economia ancora debole per le code della Grande depressione. Ora l’America ha un ritmo di crescita sostenuto e l’inflazione è stata domata da poco. E, forse, non del tutto e i dazi non sono una tassa sugli esportatori, come dice lui: li pagano i consumatori finali americani. E dal Messico, oltre a frutta, verdura e carne, arrivano anche auto, frigoriferi, schermi tv, computer. Glielo dicono, ma lui non ascolta nessuno”.
Peraltro, è lo stesso Trade Data Monitor a dirci che le importazioni negli Usa di beni dall’Ue, dal Canada, dal Messico e dalla Cina sono arrivate al valore di 1,9 trilioni di dollari, circa il 60% dell’intera importazione di merci (dato utilizzato da Trump al fine di “liberare” il mercato e rilanciare la produzione americana, ma anche potenziale “bomba atomica” economica qualora l’interruzione, il dimezzamento di questo enorme volume di importazione di merci finisse per inficiare la stessa catena produttiva e rialzare i prezzi del consumo interno). Ancora: secondo uno studio dell’università di Yale (New Haven, Connecticut) le tasse sulle importazioni colpirebbero duramente i cittadini americani ed ogni famiglia dovrebbe sostenere una spesa annuale maggiorata di 1.300 dollari. E in un editoriale del Washington Post, collocato su posizioni liberal-democratiche, uscito lo stesso giorno dell’entrata in vigore dei dazi, si scrive: “La guerra commerciale di Trump non ha nessun senso e renderà l’economia degli Usa meno competitiva”.
Come leggere, dunque, in questo contesto differenziato, la linea di Trump, che tuona, peraltro, “dazio è la parola più bella del vocabolario”? Davvero, come sostiene, Ian Brenner, direttore di Eurasia, Trump prima spara e poi si chiede il perché? Oppure la nuova guerra doganale – sia che parta dal 4 febbraio o sia rinviata-, il nuovo protezionismo americano sono inclinazioni oggettive e trovano le proprie basi materiali nella storia stessa del capitalismo Usa e mondiale, su di una strategia di fondo che segna di sé le classi dominanti nordamericane, su di una pulsione politica profonda, irrefrenabile quanto oscura e drammatica per il mondo? Siamo per questa seconda tesi, ma dobbiamo argomentarla.
Intanto: per motivi che andrebbero anch’essi indagati si è costituito una sorta di automatismo politico-intellettuale per cui quando si parla di isolazionismo e protezionismo si pensa immediatamente e solamente a quello statunitense degli anni ’20. In verità (risiede in ciò il meccanismo censorio, volto in qualche modo a salvaguardare l’immagine del capitalismo?) la linea del protezionismo attraversa l’intera storia del capitalismo. Per stare in un editoriale siamo costretti ad una sintesi rozza. La seguente: già nel XVII e XVIII secolo si presenta nel divenire capitalista una prima forma di protezionismo: il mercantilismo, tendente a puntare sull’economia interna e limitare al massimo le importazioni. Nel pieno del XVIII secolo il capitalismo, pur virando verso la libera concorrenza, utilizza ancora il protezionismo per proteggere i settori economici più deboli (agricoltura e nuove aree industriali). Che il protezionismo alligni nelle fibre più profonde del capitalismo lo dimostra il fatto che nel XIX secolo esso giunge a dotarsi di una potente teorizzazione, sia attraverso l’opera Lo Stato commerciale chiuso (1800) di Johan Gottlieb Fichte, che attraverso l’altra opera, Il Sistema nazionale di economia politica (1803) di Friedrich List, dalla quale emerge una forte critica al mercato libero. Il protezionismo, volto a ricostruire le industrie distrutte dai conflitti, riappare vigorosamente, nella forma piena di politiche statuali, nel capitalismo europeo successivo alle guerre napoleoniche, prima in Francia, Inghilterra ed Austria e poi in tutto il continente. Poiché questo non è un trattato di economia dobbiamo sorvolare il tempo: attorno al 1840 la ripresa economica europea sfocia di nuovo nel libero scambio, ma già dal 1873 una profonda e vasta crisi economica spinge i Paesi europei (tranne l’Inghilterra) ad una nuova e ferocissima politica protezionista generalizzata, da cui nascono le grandi “guerre commerciali” che si sarebbero offerte come basi materiali, peraltro, di nuovi e potenti nazionalismi (l’Italia col protezionismo della Sinistra storica e la Germania di Bismark). Il protezionismo segna di sé le economie europee e americana sino alla prima guerra mondiale, per poi strutturarsi ancor più tra le due guerre, dopo la drammatica crisi di Wall Strett del 1929 e la Grande Depressione, che spingono le economie capitaliste a ferree chiusure nazionali. Sarà nella fase successiva alla Seconda guerra mondiale che si aprirà una pratica del multilateralismo e della vasta libertà degli scambi, anche a partire dalla Conferenza di Bretton Woods del 1944, che “ratifica” sia la fine dell’isolazionismo americano che la nuova supremazia del dollaro. Sarà poi a partire dalle crisi energetiche che si espandono tra il 1973 ed il 1976 che si manifesteranno nuove spinte, nel mondo capitalista, di tipo protezionista.
Tutto ciò per affermare che il nuovo protezionismo di Trump, al di là dei singulti che lo segneranno, come questo del 5 febbraio con la transitoria concessione di un mese di trattative con Messico e Canada, non è affatto un inedito nella storia del capitalismo, ma una sua costante. Lo stesso John Maynard Keynes, negli anni ’30, prende le distanze dal libero mercato per apprezzare alcuni elementi importanti della “protezione” dei mercati interni e delle economie nazionali. E, per collocarsi nell’oggi, è lo stesso economista Ha-Joon Chang (considerato da Prospect uno dei venti migliori pensatori al mondo) a sostenere che i più forti degli odierni Paesi capitalisti hanno costruito le loro fortune attraverso politiche contrarie al libero commercio e al laissez-faire, sostenendo le industrie nazionali attraverso sussidi e politiche tariffarie sfavorevoli alle merci d’importazione. Ha-Joon Chang afferma inoltre che sono stati Gran Bretagna e Stati Uniti ad utilizzare, molto più di altri Paesi, le politiche protezioniste per divenire le più grandi potenze imperialiste, volte al dominio politico, economico e militare mondiale. Peraltro, è per tutte queste ragioni politico-teoriche di fondo che Friedrich Engels aveva già affermato (in Dazio protettivo e libero scambio) che “Il protezionismo è nel caso migliore una vite senza fine che mai smette di girare”.
Poiché siamo antipositivisti e antimeccanicisti e sappiamo che molti e non preventivabili ostacoli sempre si materializzano lungo ogni tragitto e disegno umano, non possiamo sapere a priori se la strategia di Trump volta a sostituire l’1.9% di trilioni di dollari di merci importate negli Usa con merci americane sarà portate a termine, se gli sarà possibile cogliere l’obiettivo. La vediamo dura e durissima, anche perché assieme ad una vasta guerra doganale, Trump dovrebbe lanciare all’interno degli Usa una grande politica di supporto del capitale nazionale, una sorta di aggiornato new deal dal carattere prettamente nazionalista, e ciò richiederebbe uno sforzo economico statuale enorme ed un progetto visionario che, pur con l’aiuto dell’odierna Silicon Valley a Trump asservita, non ci paiono alla portata né dell’attuale presidente nordamericano né del suo rozzo, violento, incolto gruppo dirigente.
Ma il punto che poniamo è un altro: anche sulla scorta della riflessione del grande Ha-Joon Chang, noi possiamo già oggi percepire come le politiche neoprotezioniste condotte da Trump (esattamente sovrapponibili alle politiche isolazioniste dell’intera storia del capitalismo, volte a rafforzare i vari capitalismi del dominio internazionale, del colonialismo e delle guerre di conquista) -al di là dei loro possibili “comes and goes”, va e vieni- casuali, non siano pistole che sparano senza un perché, ma siano il prodotto della forsennata spinta alla guerra finale contro il mondo multipolare che l’imperialismo Usa nasconde (malamente) in sé, una guerra da preparare attraverso un rafforzamento della grande economia e della finanza americana e dell’intero apparato militare-industriale statunitense, e ciò anche attraverso un contemplato attacco alle condizioni di vita del popolo americano. La postura degli Usa, nella propria bolla protezionista ed isolazionista, appare quella di una belva che si raccoglie in sé, tirando i muscoli, per spiccare poi il balzo per l’agguato di guerra.
Gli obiettivi del rafforzamento economico-finanziario interno (a partire da quello del complesso militare-industriale) attraverso il progetto strategico del protezionismo; l’acutizzazione scientemente perseguita delle contraddizioni internazionali attraverso l’isolazionismo; il progetto volto a far pagare la guerra mondiale, o “a pezzi”, agli Stati e ai popoli dell’Ue, ci consegnano l’immagine di una tigre americana (che non è e non mai stata “una tigre di carta”, ma una belva disposta ad un massacro mondiale al fine di perpetuare il proprio regno nella jungla del mondo) come pericolo numero uno della pace e degli interessi dei popoli del mondo. Che ogni popolo deve combattere portando fuori il proprio Paese dall’orbita imperialista e dell’Alleanza Atlantica.
Per questi obiettivi noi lavoriamo, in Italia e a partire dal progetto dell’unità dei comunisti e della costruzione del partito comunista quale perno e parte unitaria di un più vasto fronte di popolo, per la liberazione del nostro Paese dal giogo imperialista e della Nato. Tutto difficilissimo ma razionale, confortati dalla dialettica di Hegel: “Ciò che è reale è razionale”.
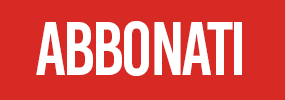

1.gif)