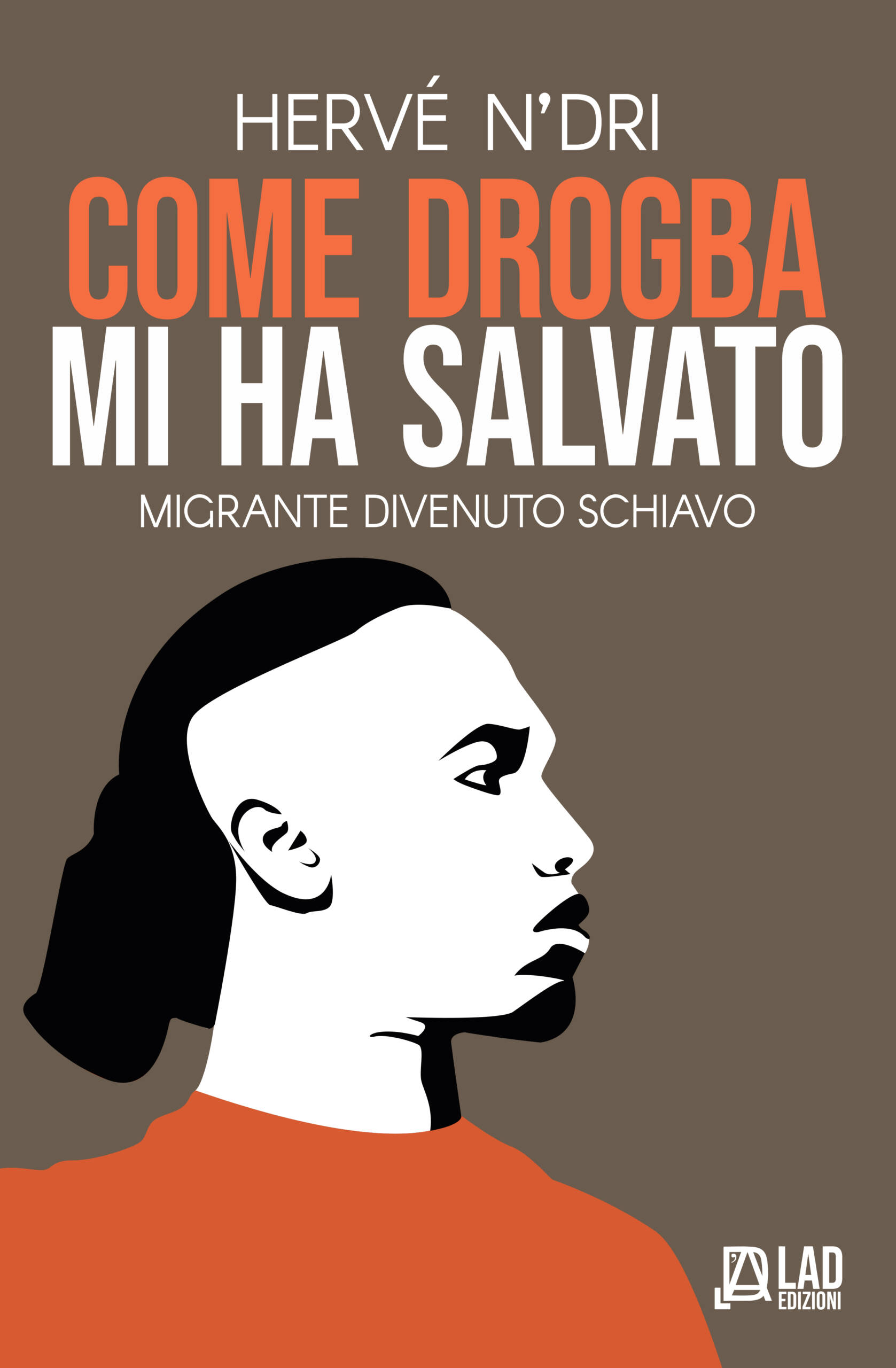L’eterno ritorno del protezionismo americano: la farsa delle tariffe
di Loretta Napoleoni
Nel mondo del XXI secolo, dove l’economia globale è intrecciata in una rete fittissima di scambi, tecnologie e capitali, gli Stati Uniti sembrano viaggiare nella direzione opposta. Non è una deviazione improvvisa, né un errore di percorso, e’ una scelta deliberata. Il ritorno al protezionismo, all’illusione che si possa chiudere il mondo fuori dalla porta, elevando muri tariffari come scudi contro la complessità del cambiamento fa parte della narrativa americana. In un lungo articolo di Bloomberg viene rivisitata la storia del protezionismo americano per giustificare quanto appena detto. Vale la pena ripercorrere questa storia per capire cosa sta succedendo negli Stati Uniti e conseguentemente nel nostro mondo.
La storia degli Stati Uniti è, fin dalla sua fondazione, una storia di protezionismo istituzionalizzato. Nel 1789, il primo Congresso non esitò a usare i dazi per proteggere gli interessi economici locali: scarpe, indaco, pesce secco — ogni prodotto aveva il suo "scudo" doganale. Alexander Hamilton, padre nobile della finanza americana, non solo giustificava queste tariffe, ma ne chiedeva l’ampliamento, per finanziare un debito pubblico crescente e per alimentare una proto-industrializzazione orientata alla conquista dei mercati interni.
La strategia era chiara: proteggere l’élite economica nascente, mascherando i privilegi dietro la retorica dell’interesse nazionale. È la stessa logica che, secoli dopo, giustifica l’imposizione di dazi su acciaio e alluminio, ignorando i costi reali per l’economia e per i consumatori. Nel XIX secolo, il protezionismo raggiunse vette parossistiche con il Tariff of Abominations del 1828. Il nome stesso — “tariffa delle abominazioni” — tradisce la portata del malcontento: un sistema costruito per avvantaggiare pochi e penalizzare molti. Ma nonostante l’opposizione, l’apparato protezionista si consolidava, ancorato alla dinamica di scambio tra potere politico e consenso locale.
La lezione avrebbe dovuto arrivare chiara con il disastro del 1930: il famigerato Smoot-Hawley Tariff Act, che alzò i dazi in un momento di recessione globale, aggravando la depressione e soffocando il commercio internazionale. La chiusura dei mercati e il collasso degli scambi furono tra le principali cause della profondissima crisi economica mondiale. Solo allora, in un estremo atto di lucidità, il Congresso ammise il proprio fallimento e cedette potere all’esecutivo attraverso il Reciprocal Trade Agreements Act del 1934. Da quel momento in poi, furono i presidenti — Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Reagan, Clinton — a guidare la politica commerciale. Non fu una rinuncia definitiva del Congresso, ma una ritirata strategica: mantenere la possibilità di influenzare senza assumersi la responsabilità diretta.
La stagione della liberalizzazione che seguì, culminata nella creazione del World Trade Organization nel 1994 e negli accordi NAFTA e USMCA, contribuì all’espansione del commercio mondiale, alla crescita del PIL globale e alla diffusione della tecnologia. Ma non curò le ferite profonde di una parte dell’America che, da allora, avrebbe visto la globalizzazione non come opportunità, ma come minaccia esistenziale. È in questo contesto di risentimento e declino delle vecchie industrie che si inserisce il ritorno delle tariffe sotto l’amministrazione Trump. Il "tariff man" ha semplicemente dato voce a una nostalgia latente, riesumando la vecchia illusione che basti alzare i prezzi dei prodotti stranieri per riportare lavoro e prosperità nelle cittadine industriali dimenticate.
E oggi? Nonostante il cambio di amministrazione, il protezionismo continua a esercitare una forza irresistibile su Capitol Hill. Le pressioni per rimettere il controllo tariffario nelle mani del Congresso non nascono da una volontà di apertura, ma da un rinnovato impulso di difendere interessi locali: fabbriche obsolete, settori decotti, illusioni di autarchia industriale. Il paradosso è evidente: in un’epoca di supply chains globalizzate e innovazione digitale, il Congresso americano rischia di tornare a un modello economico ottocentesco. E lo fa ignorando la lezione più importante del passato: che la prosperità non nasce dalla chiusura, ma dall’apertura e dalla capacità di adattarsi.
Eppure, il protezionismo continua ad avere un forte appeal tra gli americani. Nonostante le evidenze storiche e economiche, una parte significativa dell’opinione pubblica percepisce i dazi come strumenti di giustizia economica. In un Paese segnato da decenni di deindustrializzazione, disuguaglianze crescenti e impoverimento delle comunità operaie, il protezionismo appare come una risposta semplice a problemi complessi.
La promessa di “riportare il lavoro a casa” risuona potentemente, soprattutto nelle aree rurali e nelle ex città manifatturiere del Midwest. È una narrazione emotiva più che razionale, che alimenta un senso di rivalsa contro le élite urbane, le multinazionali globali e le "minacce esterne" percepite. Anche se gli economisti avvertono che i dazi aumentano i costi per i consumatori e riducono la competitività delle imprese, queste conseguenze sono spesso invisibili nel breve termine, mentre l’effetto psicologico di "punire l’estero" è immediato e gratificante. Non è tanto un amore per il protezionismo, quanto un profondo bisogno di riscatto economico e identitario.
Ma questo sentimento popolare non nasce nel vuoto: è abilmente coltivato e manipolato. Politici, media e gruppi di interesse soffiano sul fuoco del protezionismo, presentandolo come una crociata patriottica contro un sistema globale percepito come ingiusto. Ogni aumento dei dazi viene venduto come una vittoria per i lavoratori americani, anche quando i dati dimostrano il contrario. In un clima di crescente sfiducia verso le istituzioni, la narrativa protezionista diventa uno strumento di consenso immediato, un'arma elettorale potente, capace di oscurare il dibattito razionale con un appello emotivo alla nostalgia di un’America che forse non è mai esistita.
La verità, come sempre, è scomoda: il protezionismo crea vincitori e vinti, e i suoi costi sono diffusi e invisibili. I dazi alzano i prezzi per tutti, rallentano gli investimenti, isolano l’economia, riducono la competitività. Ma i benefici, per pochi settori privilegiati, sono immediati, tangibili, fotografabili — perfetti per una narrazione politica che cerca scorciatoie facili e slogan da campagna elettorale. Il paradosso finale è tragico: in un mondo che premia l'innovazione, la flessibilità, l'apertura, l’America rischia di condannarsi da sola a un declino lento ma inesorabile, ripetendo gli stessi errori di un passato che si rifiuta ostinatamente di superare.
Perché la storia insegna una verità brutale: il protezionismo dà l’illusione della sicurezza, ma porta sempre, inesorabilmente, al declino.
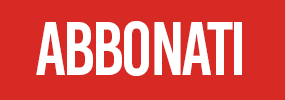

1.gif)