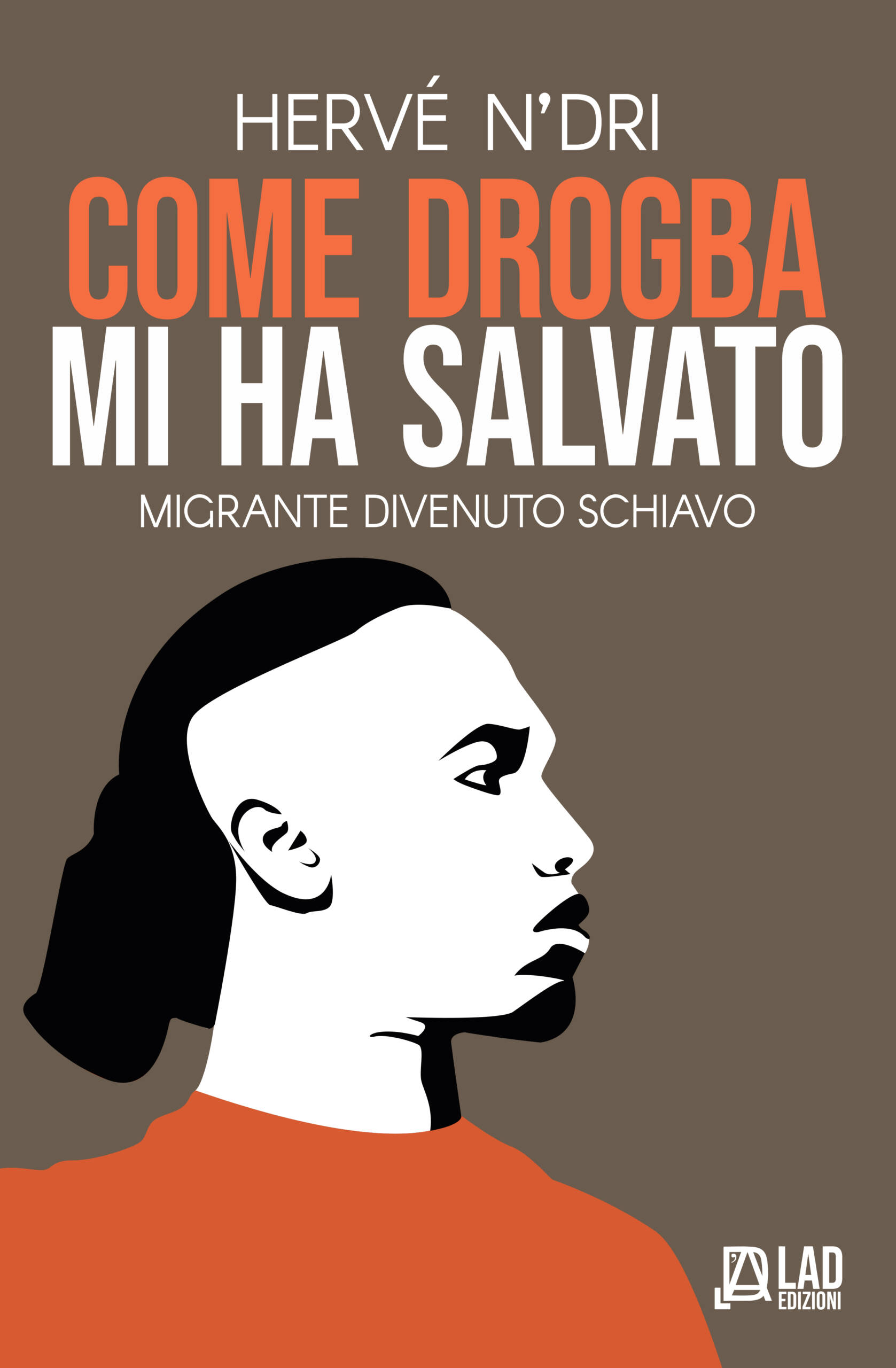Patriottismo e internazionalismo nell'eredità di Garibaldi
“E’ dovere dei popoli liberi, e che vogliono essere tali, di accorrere dovunque si combatte per i diritti delle nazioni, dovunque s’innalza la bandiera della libertà. [...] La causa della libertà è una sola, qualunque sia il nemico che la combatte, qualunque il popolo che la difende, qualunque sia il colore della bandiera sotto cui si schierano gli eserciti”1.
La fondamentale identità tra internazionalismo e patriottismo, tra la libertà di un popolo e quella dell’intera Umanità, un’identità ben espressa da queste parole di Giuseppe Garibaldi. Proprio il rivoluzionario italiano incarnò forse più di ogni altro con la sua vita e le sue opere questa identità, mettendo la sua spada al servizio non solo della rivoluzione italiana, venendo per questo ferito, perseguitato e costretto all’esilio, ma di tutte le lotte per la difesa della libertà, dall’America Latina alla Francia.
Patriottismo e internazionalismo non rappresentano due diverse disposizioni di cui si dovrebbe operare una sommatoria, ma due applicazioni conseguenti del medesimo principio. Patriottismo e internazionalismo per questo non si negano, ma sono anzi profondamente uniti. Ciò è vero sia che si esamini da un punto dello slancio ideale, sia che si voglia porre sotto esame l’aspetto pratico.
Lo stesso sentimento che porta a riconoscere nel proprio vicino qualcuno di simile sulla base della condivisione di un percorso storico particolare sta alla base del riconoscimento dell’altro, vicino o lontano, della comune appartenenza all’Umanità. Per sua stessa natura il patriottismo non può essere “esclusivo”, pena la negazione di se stesso; similmente l’internazionalismo non può che porre le sue basi in un universalismo astratto, cosa che lo confinerebbe nel mero esercizio retorico e intellettuale. Nazionale e internazionale sono quindi uniti e reciprocamente necessari, due livelli d’appartenenza di pari valore che caratterizzano l’uomo: “In quanto Antonino, Roma è mia città e mia patria; in quanto uomo, il mondo. Unico bene per me è quindi soltanto ciò che giova a queste due città”2.
Tutto ciò è perfettamente verificabile nella pratica: qualsiasi progettualità politica che affermi l’unità del genere umano si deve necessariamente fondare sull’indipendenza nazionale e la pari dignità dei popoli, e a sua volta la libertà delle nazioni non può veramente esistere fintanto che esistono rapporti gerarchici tra di esse, rapporti che incatenano tanto l’oppresso quanto l’oppressore. In una sua lettera alla figlia di Marx, Laura, Friedrich Engels espresse pienamente questo collegamento concreto tra il piano nazionale e quello internazionale: “L'unione internazionale può esistere solo tra nazioni, la cui esistenza, l'autonomia e l'indipendenza in materia di questioni interne è quindi è inclusa nel termine stesso di internazionalità”3.
Ogni reale esperienza rivoluzionaria, ogni percorso di costruzione socialista ha sempre riconosciuto la fondamentale unità di internazionalismo e patriottismo. Il nichilismo nazionale, il rifiuto della realtà materiale rappresentata dal proprio paese, dalla sua Storia e dal suo popolo equivale a un netto rifiuto di qualsiasi futuro: non è un caso che tutti coloro che hanno ammantato nel tempo la negazione della nazionalità con fraseologia rivoluzionaria non siano mai riusciti ad andare al di là di uno sterile ribellismo disobbediente.
La Storia italiana ci mostra numerosi esempi di come patriottismo e internazionalismo convivano all’interno della lotta politica dei rivoluzionari. Se l’esempio di Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei due mondi, è sicuramente il più noto, accanto ad esso ne esistono centinaia di altri: italiani accorsi a combattere, e morire, per la causa della libertà lontani dalla propria patria e stranieri che hanno contribuito alla lotta per la liberazione e l’indipendenza dell’Italia. Conoscere le loro vicende permette di acquisire grandi risorse necessarie per qualsiasi lotta di liberazione e trasformazione della società.
La ‘Garibaldi Guard’
Tra il 1820 e il 1870 furono circa 25.000 italiani che lasciarono il proprio paese per gli Stati Uniti, prime avanguardie di quell’immenso flusso migratorio che nei decenni successivi avrebbe portato più di cinque milioni di loro connazionali a seguirli. La maggior parte di loro provenivano dalle regioni del Nord e trovarono casa a New York. E’ proprio da questa città che sarebbero stati reclutati la maggior parte degli italiani che avrebbero prestato servizio nell’esercito federale durante la guerra civile.
Non si trattava solo di immigrati spinti dalle necessità economiche a vestire la divisa unionista a partire dal primo appello di Lincoln dopo la resa di Fort Sumter nell’aprile del 1861, ma anche volontari motivati, diversi dei quali giunti direttamente dall’Italia. Tentativi di creare un’unità militare completamente formata da italiani vennero fatti sin dalle prime settimane di guerra, come quello di Alessandro Repetti, tipografo federalista giunto negli USA nel 1959, e Francesco Secchi de Casali, editore del giornale L’Eco d’Italia, che promossero la creazione di una Legione Italiana, o quello del colonnello Luigi Tinelli, che provò a costruire un proprio reggimento, il ‘First Foreign Rifles’, ma questi ebbero un successo limitato a causa del numero relativamente scarso di italiani residenti a New York. Nonostante dei volontari risposero alla chiamata sia a New York che in Italia, con gli uffici consolari a Torino costretti a dover gestire un gran numero di uomini che chiedevano di potersi arruolare4, il loro numero complessivo non fu sufficiente per creare un’unità militare autonoma. Si optò quindi per la creazione di un reggimento multi-nazionale, che prese il nome di 39° Reggimento volontario di fanteria ‘New York’, detto ‘Garibaldi Guard’.
Il riferimento al rivoluzionario italiano non era casuale. Il suo nome era ormai da decenni simbolo di lotta per la libertà su entrambe le sponde dell’Atlantico, e la recente fulminea campagna militare che aveva portato al tracollo della monarchia borbonica non aveva fatto altro che far crescere ancora la sua popolarità. Moltissimi ex-garibaldini, il cui ingresso nel Regio Esercito era stato impedito dai vertici conservatori del sistema sabaudo, si offrirono volontari per combattere nell’esercito di Lincoln. Nemmeno questo deve sorprendere: tra le poche repubbliche al mondo, gli Stati Uniti erano percepiti come uno dei paesi più progressisti al mondo, e la guerra iniziata contro gli Stati meridionali, intenzionati a conservare l’istituzione della schiavitù, resa nuovamente redditizia grazie alla crescente domanda di cotone da parte dell’Inghilterra provocata dall’avanzare dell’industrializzazione del settore tessile, veniva associata alla lotta per la democrazia sostanziale e per il progresso, nonostante le ambiguità razziste di buona parte della classe dirigente nordista.
Al di là della retorica e della propaganda, la Guerra civile fu una dura lotta tra l’elemento progressivo della società statunitense, la classe borghese, il proletariato urbano e i contadini liberi dell’Ovest, e quello regressivo, i latifondisti schiavisti del Sud. La costruzione di una società capitalista moderna esigeva politiche economiche e sociali antitetiche rispetto agli interessi dei grandi piantatori meridionali, che per decenni erano stati in grado di influenzare profondamente la politica federale. Non solo la schiavitù doveva essere superata, ma il libero commercio avrebbe dovuto cedere il passo a politiche protezioniste capaci di proteggere la nascente industria americana, e lo Stato federale avrebbe dovuto vedere aumentati i propri poteri a discapito dell’autonomismo statale. Convergenti agli interessi economici della borghesia industriale e della finanza vi erano anche quelli dei contadini liberi, schiacciati dalla concorrenza delle piantagioni schiavistiche, del proletariato urbano, che dall’espansione industriale avrebbe potuto trovare maggiore certezza occupazionale, e della popolazione afrodiscendente, concentrata a Sud e composta quasi esclusivamente da schiavi. Per quanto una mentalità razzista fosse diffusa anche a Nord, come testimoniano le campagne genocide nei confronti dei nativi americani e dalla legislazione che permetteva agli schiavisti di inseguire le proprie “proprietà” fuggite anche attraverso i confini statali, il movimento democratico e favorevole all’emancipazione godeva lì di una discreta popolarità, e fu in grado di influenzare il Partito Repubblicano perché esso sostenesse misure abolizioniste, per quanto “controverse” nel panorama politico contemporaneo. Ciò si tradusse nella proclamazione del XIII emendamento nel 1864, con il quale venne abolita la schiavitù, ma anche, e soprattutto, gli emendamentio e la legislazione successiva all’assassinio di Lincoln, provvedimenti ottenuti in un clima reso molto teso dall’atteggimento conciliatorio verso gli ex-separatisti del presidente Johnson e la cui applicazione fu possibile essenzialmente per l’occupazione militare degli Stati meridionali da parte dell’esercito federale. Con il consolidamento del Partito Democratico e il raggiungimento di un’intesa tra la borghesia industriale e la grande proprietà latifondistica meridionale l’esercito venne ritirato, e la popolazione afroamericana perse progressivamente i diritti democratici conquistati negli Stati del Sud, con l’espulsione dei propri rappresentanti dagli organi elettivi e l’imposizione delle cosiddette “leggi Jim Crow”. Il regime di white supremacy codificato negli ultimi anni del XIX Secolo non è stato il prodotto necessario della Guerra civile, ma il risultato dei concreti rapporti di forza tra le classi. Se l’ala radicale del Partito Repubblicano, al Sud composto in buona parte da neri, fosse riuscita ad imporre la distribuzione delle terre agli ex-schiavi, come venne tentato a più riprese, il potere dei latifondisti sarebbe crollato, e con esso le basi economiche della supremazia bianca.
Il carattere progressivo della causa dell’Unione era ben chiaro a tutti i settori del movimento rivoluzionario europeo. Il generale Garibaldi, raggiunto da un'offerta proveniente da ambienti governativi, si rese disponibile a scendere in campo alla testa dell’esercito federale se si fosse dichiarata l’abolizione della schiavitù obiettivo manifesto della guerra, cosa non ancora accaduta nel 1862, mentre lo stesso Karl Marx, inviando a Lincoln le sue congratulazioni a nome dell’Internazionale in occasione della sua rielezione nel gennaio del 1865, testimoniò il riconoscimento del carattere politico progressivo della lotta del Nord contro una vera e propria controrivoluzione reazionaria: ”Fin dall'inizio della titanica lotta americana, i lavoratori europei sentirono istintivamente che la bandiera a stelle e strisce portava con sé il destino della loro classe. La contesa per i territori che aprì la terribile epopea non doveva forse decidere se il suolo vergine di immensi territori dovesse essere sposato con il lavoro dell'emigrante o prostituito con il calpestio dello schiavista? Quando un'oligarchia di 300.000 schiavisti osò iscrivere, per la prima volta negli annali del mondo, “schiavitù” sul vessillo della Rivolta Armata, quando negli stessi luoghi in cui appena un secolo fa era sorta l'idea di una grande Repubblica Democratica, da cui fu emessa la prima Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e fu dato il primo impulso alla rivoluzione europea del XVIII secolo; quando proprio in quei luoghi la controrivoluzione si gloriava, con sistematica accuratezza, di cancellare “le idee sostenute al momento della formazione della vecchia costituzione”, e sosteneva che la schiavitù fosse “un'istituzione benefica”, anzi, la vecchia soluzione del grande problema del “rapporto tra capitale e lavoro”, e proclamava cinicamente la proprietà dell'uomo “la pietra angolare del nuovo edificio” - allora le classi lavoratrici d'Europa capirono subito, anche prima che la fanatica partigianeria delle classi altolocate per la nobiltà confederata desse il suo lugubre avvertimento, che la ribellione degli schiavisti avrebbe suonato il tocsin di una santa crociata generale della proprietà contro il lavoro, e che per gli uomini del lavoro, con le loro speranze per il futuro, persino le loro conquiste passate erano in gioco in quel tremendo conflitto sull'altra sponda dell'Atlantico. Ovunque, quindi, sopportarono pazientemente le difficoltà imposte loro dalla crisi del cotone, si opposero con entusiasmo all'intervento pro-schiavitù dei loro superiori e, dalla maggior parte dell'Europa, contribuirono con la loro quota di sangue alla buona causa”5.
Scegliendo di combattere sotto la bandiera tricolore sormontata dalla scritta “Dio e Popolo”, la stessa che accompagnò la Repubblica Romana del 1849, i volontari italiani della Garibaldi Guard testimoniavano un impegno politico che andava oltre alla semplice fedeltà verso uno Stato minacciato da forze separatiste, mettendo al centro la causa dell’emancipazione umana. Accanto a loro vi erano soldati provenienti da diversi paesi europei. Il 39° reggimento venne infatti costituito da dieci compagnie così ripartite: tre tedesche, tre ungheresi, una svizzera, una italiana, una francese, una portoghese e una spagnola. Il comando venne inizialmente assegnato al colonnello ungherese Frederick d’Utassy, il quale venne successivamente trovato colpevole di numerosi crimini, dalla corruzione al favoreggiamento della diserzione, e per questo congedato con disonore.
La Garibaldi Guard prese parte a decine di combattimenti contro le forze confederate, distinguendosi in particolare alla battaglia di Gettysburg, quando, come parte del II Corpo dell’Armata del Potomac, fu schierata al centro dell’ala sinistra durante le giornate del 2 e 3 luglio 1863, perdendo 95 soldati e 9 ufficiali. Complessivamente, nel corso della guerra furono più di trecento le vittime subite dal reggimento, che venne sciolto nel 1865.

Francesco Federico Falco
Nativo di Penne, in Abruzzo, Francesco Federico Falco è stato chiamato “l’altro eroe dei due mondi”, come titola un libro su di lui pubblicato nel 2010. Effettivamente la vita di Falco ha diversi punti in comune con quella di Garibaldi, in quanto anch’egli divise la sua militanza rivoluzionaria tra l’Italia e l’America Latina.
Iniziò la sua attività politica appena ventenne, avvicinandosi al tardo movimento mazziniano con l’iscrizione al Partito Repubblicano, dal quale uscì verso fine secolo abbracciando posizioni più chiaramente socialiste. Durante questi anni fu particolarmente attivo a livello giornalistico, firmando articoli su quotidiani come L’emancipazione, La scintilla e Il popolo toscano. Nel 1896, dopo lo scoppio dell’ennesima insurrezione indipendentista a Cuba contro il dominio coloniale spagnolo e la morte di celebri patrioti cubani come Antonio Maceo, il ‘Titano di bronzo’, e José Martí, Falco fu tra i fondatori di un comitato di solidarietà alla rivoluzione cubana. Due anni dopo, assieme a 75 volontari, partì alla volta dell’isola per consegnare il denaro raccolto con le sottoscrizioni e offrirsi come volontario.
Federico Falco fu nominato comandante del Corpo di sanità militare dell’esercito rivoluzionario, ma continuò anche l’attività giornalistica fondando La cultura latina, giornale in lingua spagnola con cui contribuì alla diffusione delle idee socialiste non solo a Cuba, ma anche sul continente, dal Messico all’Argentina, passando per il Venezuela.
Critico dell’intervento statunitense nel conflitto, con il quale si inaugurò un cinquantennio di dominio ‘yankee’ sull’isola, Falco continuò a cooperare con le autorità cubane anche dopo la cacciata degli spagnoli, dando alla luce un’ampia produzione accademica e venendo premiato nel 1903 con il ruolo di console generale per la città di Genova, diventando nel 1920 plenipotenziario de L’Avana in Italia.
Grazie alla copertura diplomatica cubana Falco poté sottrarsi alla repressione fascista, pur dovendo affrontare difficili situazioni economiche. Morì a Livorno nel 1944.

Ilio Barontini
Nato nei pressi di Livorno nel 1890 in una famiglia d’origini contadine, Ilio Barontini si dedicò sin da giovane alla lotta politica, iscrivendosi a quindici anni al Partito Socialista Italiano e promuovendo l’organizzazione degli operai nelle aziende in cui si trovò a lavorare, dalle ferrovie al cantiere Orlando di Livorno. Passata la Prima guerra mondiale come “operaio mobilitato” presso le officine Breda di Milano, Barontini si schierò successivamente sulle posizioni de L’Ordine Nuovo di Antonio Gramsci, rompendo col PSI e contribuendo alla fondazione del Partito Comunista d’Italia e all’organizzazione del partito nella sua città. Davanti all’avanzata del fascismo egli promosse l’organizzazione degli Arditi del Popolo, in controtendenza rispetto a numerose voci interne al PCdI. Con l’avvento della dittatura alle violenze si accompagnò una persecuzione giudiziaria sempre più accanita da parte del Tribunale Speciale. Nel 1931, su indicazione del partito, espatriò in Francia passando attraverso la Corsica. Arrivato a Parigi facendossi passare per un commerciante svizzero, collaborò alla gestione dei rapporti tra l’emigrazione antifascista e gli esponenti del movimento d’opposizione clandestino rimasti in Italia. Nel 1933 si trasferì a Mosca.
In Unione Sovietica Ilio Barontini alternò il lavoro di fabbrica alla formazione politica presso la Scuola leninista internazionale di Mosca e all’addestramento militare all’Accademia Frunze. Migliaia di altri rivoluzionari, provenienti da ogni angolo del pianeta, stavano negli stessi anni compiendo percorsi simili. Le autorità sovietiche favorivano così la formazione di quadri dirigenti politici e militari capaci di portare avanti la lotta per il socialismo tanto nei paesi occidentali, quanto nei paesi coloniali, in qualità di quadri di partito o inviati della Terza Internazionale. Ilio Barontini seguì proprio questa strada, venendo mandato in missione in Cina tra 1934 e 1935, proprio nei mesi della Lunga Marcia. Questo periodo della sua vita, poco documentato, fu probabilmente di grande importanza in quanto lo mise direttamente in contatto con le dinamiche di una lotta di liberazione condotta attraverso la guerriglia e fondata sul supporto popolare.
Con la sollevazione militare filo-fascista del 17 luglio 1936 ebbe inizio la Guerra civile spagnola. Dopo la presa del potere di Hitler in Germania e gli avvicinamenti diplomatici tra il Terzo Reich e gli Stati occidentali, si pensi all’accordo navale tra Germania e Regno Unito del 1935 o il patto di non aggressione tra Berlino e Varsavia dell’anno precedente, il contesto internazionale rendeva necessaria un’intensificazione della lotta contro il pericolo fascista. Non è un caso che il VII congresso dell’Internazionale comunista, tenutosi nel 1935, avesse messo al centro la questione dell’analisi del fascismo e dello sviluppo degli strumenti politici utili alla lotta contro di esso, soprattutto tramite la relazione del comunista bulgaro Georgi Dimitrov. Conseguentemente, l’Unione Sovietica fu in prima fila nel fornire supporto alla Repubblica Spagnola, dove già le forze comuniste esercitavano un ruolo di primo piano nella vita politica del paese. La stessa linea fu condivisa dal movimento comunista internazionale: in migliaia accorsero a combattere contro le forze golpiste nelle fila delle Brigate Internazionale. Ilio Barontini fu uno di questi.
Sin dalle prime settimane del conflitto tra gli esuli antifascisti italiani si diffuse la volontà di formare reparti volontari per affiancare i regolari repubblicani nelle operazioni belliche. Nell’ottobre del 1936 si riuscì a trovare un accordo politico tra comunisti, socialisti e repubblicani per la creazione di una formazione militare affidata al comando del veterano della Grande Guerra Randolfo Pacciardi, affiancato da i comunisti Antonio Roasio e Luigi Longo e dal socialista Amedeo Azzi. Nacque così il Battaglione ‘Garibaldi’, facente parte della XII Brigata Internazionale assieme ai battaglioni ‘Thalmann’, composto da volontari tedeschi, ‘André Marty', francese, e dal battaglione ‘Dombrowsky’, costituito da miliziani dell’Europa orientale.
Il ‘Garibaldi’ partecipò a diversi scontri, tra cui sanguinosi ingaggi a difesa di Madrid, come quelli presso la Puerta de Hierro e la Città universitaria. Durante la battaglia di Jarama Pacciardi venne ferito alla testa, e venne per questo motivo sostituito temporaneamente da Ilio Barontini, appena nominato commissario politico al posto di Roasio. Barontini si trovò così a guidare il Battaglione ‘Garibaldi’ durante la battaglia di Guadalajara, che, svoltasi tra il 7 e il 19 marzo 1937, vide per la prima volta lo scontro tra i volontari antifascisti italiani e le truppe inviate da Mussolini a supporto del golpe militare di Francisco Franco. Il battaglione ‘Garibaldi’ arrivò a Guadalajara il 10 marzo, due giorni dopo l’inizio dell’offensiva fascista, portata avanti in particolare delle divisioni di Camicie Nere ‘Penne nere’ e ‘Fiamme nere’. Nelle due settimane successive, segnate dal contrattacco repubblicano, i volontari italiani si distinsero eroicamente riuscendo a più riprese a sopraffare e costringere alla ritirata i reparti fascisti. Guadalajara passò alla Storia come la prima sconfitta del fascismo, caricandosi di un significato morale e propagandistico forse anche superiore alla sua importanza strategica.
A seguito del ritiro delle Brigate Internazionali, voluto dagli Stati occidentali e ordinato nell’autunno del 1938 dal primo ministro spagnolo Juan Negrin, Ilio Barontini tornò in Francia, dove rimase per poche settimane prima di venir inviato dal Comintern in un altro fronte della lotta antifascista internazioanale: l’Etiopia.
Tra il 2 e il 3 ottobre 1935 il regime mussoliniano aveva dato il via all’invasione dell’Etiopia, unico lembo di territorio africano, oltre alla Liberia, rimasto libero dalla colonizzazione europea. Come già espresso nel 1914 da Gaetano Salvemini in riferimento alla Libia, la politica coloniale italiana era stata da sempre “cieca”, dominata da retorica e pressapochismo6, priva di un respiro strategico e costretta ad accontentarsi delle “briciole” lasciate dalle potenze imperialiste. L'espansione coloniale era vista da un lato come questione di prestigio, elemento necessario per affermare l’Italia sul piano internazionale come parte del club dei “grandi”, dall’altro come utile valvola di sfogo per la pressione demografica delle campagne e per la disoccupazione. A seguito della chiusura parziale dei confini statunitensi all’immigrazione, in particolare a quella proveniente dall’Asia e dall’Europa meridionale, si perse quello che per decenni era stato il principale strumento di contenimento della tensione sociale. La ripresa fascista dei progetti di colonizzazione della Libia e dell’Africa orientale rispondeva anche alla necessità di garantire terreni assegnabili a milioni di contadini impoveriti. L’imperialismo, ancora una volta, si mostrava (anche) una “questione di stomaco”, come affermato nel 1895 da Cecil Rhodes.
Dopo alcune settimane di difficoltà iniziali, il grande esercito d’invasione guidato da Badoglio e Graziani riuscì a sconfiggere le truppe regolari etiopi, anche grazie all’utilizzo di armi chimiche. Le forze fasciste entrarono ad Addis Abeba il 5 maggio, mentre il negus Hailé Selassié riparava in Gran Bretagna. Il 9 maggio 1936 Mussolini proclamò a Roma la nascita dell’Impero. Nonostante ciò la guerra non poteva dirsi finita. Al di là delle principali città e di fortini isolati, il regime fascista non era in realtà in controllo del paese: ovunque si diffuse la lotta di resistenza degli Arbegnuoc, i ‘patrioti’ etiopi, composti sia da soldati dell’esercito sconfitto che da volontari contadini, spesso sostenuti, o guidati, anche dai vari ras locali che avevano scelto di non percorrere la strada della conciliazione con le nuove autorità coloniali, in genere non disponibili al dialogo.
Barontini arrivò in Etiopia nel dicembre del 1938, venendo raggiunto poche settimane dopo dai comunisti Domenico Rolla e Anton Ukmar. Essi presero come nomi di battaglia rispettivamente “Paolo”, “Pietro” e “Giovanni”, il cui chiaro richiamo biblico ben veniva accolto dalla religiosa popolazione etiope. La missione dei “tre apostoli” era quella di organizzare la resistenza etiope e di distribuire propaganda antifascista tra i soldati e i coloni italiani. A tal fine venne da loro creato anche un giornale bilingue, La voce degli Abissini. barontini riuscì in poco tempo ad organizzare una forza guerrigliera composta da 250.000 combattenti, aventi a capo un governo provvisorio formato da nove ministri e operanti principalmente nel Gondar e nel Goggiam. Per il suo servizio il negus d’Etiopia gli conferì il titolo di “vice-imperatore”.
Barontini venne richiamato in Europa allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, passando attraverso il Sudan e raggiungendo Marsiglia via nave da Il Cairo, pochi giorni prima dell’occupazione di Parigi da parte delle forze naziste. Assieme ad altri italiani venne quindi internato nel campo di concentramento di Vemet, dal quale riuscì ad uscire grazie all’azione diplomatica sovietica. Datosi alla clandestinità, Barontini aiutò nell’organizzazione della resistenza francese nella Provenza, ricoprendo incarichi dirigenziali coordinando l’azione di numerosi antifascisti italiani che l’avrebbero seguito nel ritorno in patria una volta caduto il regime fascista. In Francia Barontini divenne esperto di guerriglia urbana e di attacchi dinamitardi, competenze che gli sarebbero state molto utili tornato in Italia.
Barontini rientrò in Italia immediatamente dopo l’8 settembre, operando in tutto il centro-nord per organizzare le brigate partigiane e i Gruppi d’Azione Patriottica. Finalmente, dopo anni di lotte all’estero, Barontini aveva l’opportunità di contribuire alla liberazione del proprio paese, dal quale era dovuto fuggire incalzato dalla repressione fascista. Le lezioni apprese nel decennio precedente furono essenziali tanto per la guerriglia in montagna quanto per le operazioni urbane dei GAP. In un’orazione funebre a lui dedicata si ebbe modo di ricordare come Barontini fosse conscio dei rischi e delle ripercussioni della lotta partigiana, ma anche di come questa fosse essenziale per riscattare l’onore e la dignità della nazione: “Si, sapevamo, Barontini sapeva che i tedeschi erano crudeli, che le loro rappresaglie erano terribili, ma egli sapeva anche che senza quelle lotte audaci e senza Quartiere non vi sarebbe stata guerra di liberazione, non saremmo stati degni degli eroi del Risorgimento Italiano, non avremmo riscattato l'onore dell' Italia e degli italiani, non avremmo conquistato il diritto di essere un popolo libero ed indipendente”7.
Nell’estate del 1944 divenne capo del Comando Militare Unico dell’Emilia-Romagna. Con questo ruolo partecipò a numerosi scontri, come quello di Porta Lame a Bologna il 7 novembre dello stesso anno e il successivo combattimento alla Bolognina.
Il 19 aprile 1945 le forze partigiane guidate da Ilio Barontini riuscirono ad espellere gran parte delle forze naziste da Bologna, sulla quale già premevano gli eserciti alleati. Il 21 aprile la città fu completamente liberata, e le formazioni partigiane poterono incontrarsi con le unità sopraggiunte, tra cui i polacchi del II Corpo e i soldati italiani del Gruppo di Combattimento ‘Friuli’.
Dopo la guerra Barontini divenne membro del Comitato Centrale del PCI e deputato dell’Assemblea costituente e senatore. Morì in un incidente d’auto a Scandicci il 22 gennaio 1951.

Elia Putzolu ed Edy Ongaro
L’inizio dell’Operazione militare speciale russa nel Donbass e in Ucraina ha inaugurato una nuova fase nella lotta internazionale contro l’imperialismo egemonico degli Stati Uniti. A seguito dell’intervento diretto russo nel conflitto scoppiato nel 2014, la lotta antimperialista internazionale ha conosciuto una rinnovata vivacità, con l’espulsione delle forze di Parigi dal Sahel, il rafforzarsi della posizione del Venezuela in America Latina e il lancio dell’operazione Tempesta di al-Aqsa da parte delle forze della resistenza palestinese. La collaborazione politica e militare tra Russia, Iran, Cina e Corea popolare si è notevolmente rafforzata, così come si è rafforzata la capacità attrattiva di strutture multilaterali anti-egemoniche come i BRICS.
Davanti all’intensificarsi del conflitto in Ucraina, l’Italia, a causa della sua sottomissione coloniale agli Stati Uniti, è stata sin da subito in prima fila nel sostegno politico e militare al regime di Kiev, alimentandone la macchina bellica e contribuendo al prolungamento del conflitto. Diversi cittadini italiani si sono persino recati a combattere come mercenari tra le fila delle milizie di Zelensky, amplificando la vergogna nazionale prodotta dalla politica di sottomissione euro-atlantista promossa dai governi di Mario Draghi e Giorgia Meloni.
Come l’onore dell’Italia macchiato dal regime fascista venne salvato dai partigiani e dai volontari antifascisti su ogni fronte, così oggi l’onore del nostro paese è salvaguardato dalle migliaia di italiani che si oppongono alle politiche belliciste filo-occidentali dell’amministrazione coloniale dell’Italia. In milioni non hanno appoggiato le politiche promosse in sudditanza di Washington e Bruxelles. Migliaia e migliaia hanno testimoniato questa opposizione con manifestazioni, petizioni, atti di solidarietà al popolo russo. Tra tutti i più meritevoli di stima sono gli italiani che hanno scelto di combattere contro il regime di Kiev come parte dell’esercito russo.
Sono numerosi i volontari italiani che dal 2014 ad oggi hanno lottato nel Donbass contro le forze ucraine, divenute truppa di sfondamento della NATO. E’ giusto ricordare in particolare due volontari italiani che sono caduti al fronte dopo l’inizio dell’Operazione militare speciale: Elia Putzolu ed Edy Ongaro.
Il 30 marzo 2022 cadeva in combattimento proteggendo i propri compagni da una granata Edy Ongaro, nome di battaglia ‘Bozambo’, 46enne originario di Portogruaro che nel 2015, mosso dai propri ideali, si era unito alla brigata ‘Prizrak’, unità precedentemente inquadrata nelle forze della Repubblica Popolare di Lugansk punto d’approdo di numerosi volontari internazionali. Proletario, militante comunista, Ongaro sentiva una stretta connessione tra il suo impegno a favore dell’autodeterminazione dei russi del Donbass e la lotta generale contro un sistema economico-sociale, quello dell’imperialismo rappresentato nella sua massima espressione dal regime egemonico statunitense, responsabile di miseria e oppressione in tutto il mondo: “Qui ci sono tanti volontari: ci sono manager moscoviti e muratori, hanno mollato tutto e sono venuti a combattere contro il fascismo. Io non chiedo a nessuno di fare l’eroe, ma il rispetto verso se stessi dovrebbe portare qui molte persone. Se potete, venite qua”8.
Pochi mesi dopo la morte di Ongaro, il 17 ottobre 2022, venne ucciso da un colpo d’artiglieria Elia Putzolu. Famiglia di origine sarda, con una nonna proveniente dall’Unione Sovietica, Elia ha passato la sua vita tra la Toscana e Milano, dove si era trasferito per lavoro, prima di arrivare in Russia. Nel 2019 si unì alla milizia della Repubblica Popolare di Donetsk, spinto dalla volontà di mettere fine alle violenze e ai crimini del regime di Kiev, prestando servizio come cecchino per allontanare il più possibile il tiro dell’artiglieria dalla città di Donetsk, martoriata dal 2014. Con queste parole lo ricorda Andrea Lucidi, giornalista che ha avuto modo di conoscere Elia, in occasione del rientro in Italia delle ceneri del caduto: “In tanti hanno provato a ricordarlo, qualcuno anche a ringraziarlo per quello che ha fatto quando era in Italia e anche quando era in Donbass. Per tanti è difficile comprendere le ragioni di una scelta tanto radicale, tanto lontana dalla logica della società occidentale; per alcuni no, alcuni lo capiscono, lo ammirano ma soprattutto in questo momento lo ricordano. Elia è stato e sarà sempre ricordato da tutti come un ragazzo meraviglioso, pieno di umanità. Una persona che si è spesa, fino all'ultimo istante di vita, per gli altri, per il suo popolo, il popolo del Donbass. Oltre al tricolore italiano, le sue ceneri sono state coperte con la bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk, la bandiera che ha servito, insieme al suo basco e alle sue decorazioni; proprio per onorare la sua scelta e il suo valore di uomo e di combattente. Nel cuore mi rimarrà sempre il suo viso sorridente, che trasmetteva serenità, il suo volersi spendere per gli altri e il suo infinito coraggio. Spero che questo nuovo viaggio che ha intrapreso possa portarlo nel cuore di tutti quelli che lo hanno amato e che lui ha amato. Come chi prima di lui è caduto combattendo per la libertà, contro le ingiustizie, è diventato un membro del Reggimento Immortale. Così noi che rimaniamo lo ricorderemo, fino al momento in cui ci rivedremo, con tutti, con tutti gli amici, con tutti i fratelli, con tutti i compagni”9.


Andrès Aguyar
Aguyar nacque attorno al 1810 a Montevideo. Entrambi i suoi genitori, come milioni di altri afrodiscendenti in tutta l’America Latina, erano schiavi, e ciò rendeva tale anche Andrés. La sua sorte avrebbe dovuto quindi essere quella di lavorare tutta la vita al servizio di un grande latifondista come semplice “attrezzo parlante”, ma lo scoppio della “Guerra grande”, il conflitto che sconvolse tra il 1839 e il 1851 nella regione del Rio de la Plata, gli aprì un destino molto diverso.
La guerra nacque come conflitto interno all’Uruguay, paese dalla recentissima indipendenza schiacciato tra l’Argentina e l’Impero brasiliano, che vedeva una forte polarizzazione politica tra una fazione liberal-borghese, i “colorados”, espressione degli interessi urbani e commerciali, e una rurale e tradizionalista, i “blancos”, composta principalmente dai grandi piantatori. Tutta la regione negli stessi anni era in subbuglio: nel 1835 aveva avuto inizio la ribellione dei farrapos nella regione brasiliana del Rio Grande, che portò l’anno successivo alla proclamazione dell’indipendenza; similmente, anche in Argentina si era verificata una guerra civile a seguito dell’indipendenza tra i “federalisti” e gli “unitari”, ancora rispettivamente connessi all’aristocrazia fondiaria e alla borghesia urbana. Questi conflitti, in genere scontri tra piccoli eserciti e formazioni irregolari, caratterizzati più dalla presenza di “signori della guerra” locali che da un grande coinvolgimento delle masse contadine, erano seguiti con attenzione dalla Gran Bretagna e dalla Francia, che, per favorire la propria penetrazione commerciale, sostenevano i gruppi più favorevoli al libero commercio. Pur rispondendo a dinamiche di potere prettamente locali, i vari scontri politici e militari finirono per intrecciarsi, soprattutto in relazione al controllo della regione del Rio de la Plata, dove Buenos Aires e Montevideo si trovano una di fronte all’altra, separate da un breve tratto d’estuario. Proprio a Buenos Aires, controllata dal federalista de Rosas, trovò riparo il presidente blanco Manuel Oribe.
Nel 1842, per spingere la popolazione nera all’arruolamento, sia i blancos che i colorados annunciarono l’emancipazione degli schiavi. Aguyar fu tra quelli che scelsero di arruolarsi con la fazione liberal-democratica, partecipando assieme ad altri 5000 ex-schiavi alla difesa di Montevideo, minacciata dall’esercito di Oribe. A sostegno del governo progressista dell’Uruguay vi era anche Giuseppe Garibaldi, già veterano dell’insurrezione riograndesa e a capo della Legione Italiana che rese celebre l’utilizzo della camicia rossa. Nel 1848, quando Garibaldi tornò in Italia in relazione agli eventi della Prima guerra d’indipendenza, Aguyar fu tra gli uomini che scelsero di seguirlo. In Italia Andrés divenne rapidamente uno dei più fedeli collaboratori di Garibaldi, seguendolo “come un’ombra”, facendogli da aiutante di campo e condividendo i pericoli della prima linea. Il pittore olandese Johan Philip Koelman, testimone della Repubblica Romana, così descrisse Aguyar: “Ercole di color ebano, in groppa ad un cavallo nero come il suo volto luccicante nel sole, faceva pensare a un’ombra, giacché stava sempre vicino al generale, il cui viso e capelli chiari e lo stallone bianco contrastavano con le tinte scure della sua ordinanza”10. Durante le battaglie a difesa della Repubblica, Aguyar salvò diverse volte la vita al suo amico e superiore, come durante la battaglia di Velletri del 19 maggio 1849, bruciante sconfitta per l’esercito borbonico, quando “il moro” protesse Garibaldi caduto da cavallo. Giornali e commentatori dell’epoca raccontano di come continuasse a combattere alla maniera “sudamericana”, usando il lazo e la lancia, e dimostrando invidiabile abilità nel cavalcare. Per le sue imprese fu promosso da Garibaldi al grado di tenente.
Proprio durante la difesa della Repubblica Romana Andrés Aguyar trovò la morte, colpito da una granata francese il 30 giugno 1849 presso l’attuale Via dei Panieri, durante uno dei violenti assalti del generale Oudinot contro la città. Il suo corpo venne steso accanto a quello di Luciano Manara, caduto nelle stesse ore durante la difesa di Villa Spada. Solo nel 2024 un busto di Aguyar è stato eretto sul Gianicolo a Roma, tra i monumenti dedicati agli altri eroi della Repubblica Romana.

Lajos Tüköry
Appena diciottenne, Lajos Tüköry, nato in una famiglia di allevatori di cavalli della piccola cittadina di Körösladány, si arruolò nell’esercito rivoluzionario che, a seguito della proclamazione d’indipendenza dall’Impero austriaco avanzata dal ministro Lajos Kossuth, tentò di liberare l’Ungheria dalla dominazione asburgica, si scontrò con le forze della Santa Alleanza, venendo infine battuto nel 1849. La repressione imperiale colpì duramente i patrioti ungheresi, con l’impiccagione di molti militanti democratici e liberali oltre che delle principali figure del comando militare rivoluzionario. Kossuth riuscì a fuggire riparando nei territori dell’Impero ottomano, mentre Tüköry, divenuto tenente combattendo in Transilvania con la 55?? Divisione, continuò a servire gli ideali della “Primavera dei popoli” con le armi in mano.
Dopo aver combattuto tra le fila del contingente turco duranta la Guerra di Crimea, su indicazione di Kossuth Lajos Tüköry si recò in Italia come parte della Legione Ungherese inviata a sostegno delle forze patriottiche italiane contro gli Asburgo. La Legione non riuscì ad intervenire direttamente nella Seconda guerra d’indipendenza, ma si mise immediatamente agli ordini di Garibaldi. Tüköry, assieme ad altri ungheresi, prese parte alla Spedizione dei Mille, distinguendosi nella battaglia di Calatafimi. Così ricorda in “Da Quarto al Volturno” Giuseppe Cesare Abba la figura di in Sicilia: “Il tenente colonnello Tüköry cavalca su e giù per la strada, esercitando un morello, che non tocca la terra da tanto che è vispo. Giovanissimo per il suo grado, quest’ufficiale mi parve l’immagine viva dell’Ungheria, sorella nostra nella servitù. La sua faccia, d’un pallido scuro, è fina di lineamenti e illuminata da un par d’occhi fulminei e mesti. Egli era a quelle battaglie di dieci anni or sono, i cui nomi strani ponevano a me fanciullo uno sgomento indicibile in cuore. Vide i reggimenti italiani al servizio dell’Austria dare il colpo di grazia alla patria sua. Ma l’amore di quella generosa nazione per noi sopravvisse. Soltanto non sappiamo quanto la nostra guerra fortunata dell’anno scorso, le sia stata funesta. Essa ha qui due rappresentanti degni, Tüköry e Türr, oltre a due gregari; quel selvaggio che vidi a bordo e il sergente Goldberg della mia compagnia, soldato vecchio, taciturno, ombroso, ma cuore ardito e saldo. Lo vedemmo a Calatafimi!”11.
Dopo la vittoria a Calatafimi il generale Garibaldi decise di marciare su Palermo. Le forze in campo erano impari: tra le Camicie rosse e gli insorti siciliani si potevano contare al massimo qualche migliaia di combattenti, mentre la città era presidiata da più di ventimila tra soldati borbonici e mercenari stranieri. Per poter liberare Palermo fu quindi necessario affidarsi all’insurrezione popolare, contando sul supporto degli abitanti della città, fortemente ostili alla dominazione borbonica.
Il 27 maggio 1860, dopo essersi avvicinate alla città nascoste al nemico, le forze garibaldine iniziarono l’assalto. Dopo essere giunti alle due di notte presso Acqua dei Corsari, gli attaccanti si disposero per l’attacco. L’avanguardia era tenuta da un manipolo di Cacciatori delle Alpi, comandato da Lajos Tüköry. Individuato dalle sentinelle borboniche, il suo gruppo diede l’attacco a Ponte dell’Ammiraglio. Lo stesso Tüköry fu il primo a superare le barricate nemiche, prima che una palla gli colpisse il ginocchio. Nonostante ciò i garibaldini poterono avanzare grazie all’azione di un altro reparto che prese alle spalle i difensori borbonici. La popolazione palermitana, appreso dell’arrivo degli uomini di Garibaldi, insorse, riuscendo a liberare la città il 30 maggio.
La ferita Tüköry costrinse all’amputazione della sua gamba, ma ciò non bastò: la cancrena lo uccise il 6 giugno 1860.

Fiodor Andrianovic Poletaev
Poletaev è l’unica persona ad essere stata insignita allo stesso tempo della Medaglia d’oro al Valor Militare della Repubblica Italiana e del titolo di Eroe dell’Unione Sovietica.
Nato nell’oblast di Rjazan’ il 14 maggio 1909 da una famiglia contadina, nel 1923 iniziò a lavorare in una torbiera nell’Oblast di Mosca, a Elektrogorsk. Qui conobbe la sua futura moglie, Maria Nikanovna Kalinina. Con lei tornò nel 1931 a Katino, suo villaggio natale, dove nel maggio dello stesso anno nacque la sua prima figlia. Lo stesso anno, dovendo prestare servizio militare, fu coscritto nella 1? Divisione di fanteria proletaria di Mosca come parte del reggimento d’artiglieria. Nel 1932 nacque il suo secondo figlio, Mikhail.
Due anni dopo essere stato smobilitato, nel 1935, suo figlio morì di poliomielite, e la figlia più grande, anch’essa colpita, sopravvisse pur rimanendo segnata da sordità e disturbi cerebrali. Trasferitosi nel villaggio di Petrushino, ebbe qui altri tre figli, una femmina e due maschi.
Nell’agosto del 1941, dopo l’inizio dell’invasione hitleriana dell’Unione Sovietica, Poletaev fu mobilitato, combattendo nella battaglia di Mosca e ai combattimenti sul Don come parte del 28° reggimento d’artiglieria della 9? Divisione di fucilieri della Guardia.
Nel luglio del 1942 la 9? Divisione prese posizioni difensive attorno al fiume Oskol, nell’oblast di Kharkov, dal quale dovette ritirarsi dopo pochi giorni trincerandosi sul fiume Derkul, nel Lugansk. Dopo questi combattimenti la divisione venne trasferita a Stalingrado, dove arrivò già il 14 dello stesso mese. Poletaev, la cui unità era stata circondata nei pressi del villaggio di Raznoldoye, venne ferito e catturato mentre cercava di riprendere contatto con le forze dell’Armata Rossa.
Nei mesi successivi fu internato in diversi campi per prigionieri di guerra attraverso l’Ucraina e la Polonia, prima di essere trasferito in una struttura nei pressi della cittadina croata di Slavonski Brod. Da qui tentò la fuga nel marzo del 1944 assieme ad un gruppo di compagni, ma venne presto catturato e trasferito nei pressi di Tortona, ancora più lontano da casa.
Con l’aiuto di alcuni partigiani comunisti italiani Poletaev riuscì nuovamente a fuggire dalla prigionia e, raggiunto a piedi l’Appennino ligure-piemontese, si unì alla 9ª Brigata "Mazzarello", confluita nell’ottobre nella 58ª Brigata "Oreste" della Divisione Garibaldi "Cichero".
Assieme ai suoi compagni italiani prese parte a numerose operazioni nella zona tra Genova e Serravalle, riuscendo a sopravvivere al duro inverno del ‘44, segnato da costanti rastrellamenti e da una diminuzione del sostegno alleato alle formazioni partigiane, in specie quelle comuniste. Tra le unità naziste impegnate nelle operazioni punitive vi erano reparti della “Legione del Turkestan", un reparto collaborazionista formato da volontari dell’Asia centrale, disertori dell’Armata Rossa.
Il 2 febbraio 1945 circa un centinaio di soldati nazisti, principalmente membri della “Legione”, attaccarono le forze partigiane che bloccavano la gola delle Strette del Petruso sul torrente Borbera, occupando il paese di Cantalupo Ligure. Unità partigiane provenienti da Cornareto e Roccaforte contrattaccarono, riuscendo ad eliminare 12 nazisti e a prenderne 41 prigionieri. Fedor Poletaev fu l’unico partigiano a cadere durante lo scontro.
“Ad una distanza impensabile dalla sua terra, Fjodor e i suoi compagni, sopportando sofferenze inumane, sfidando la morte, ogni minuto, ogni giorno sentivano di appartenere a una formazione di battaglia -soldati semplici della potente e invincibile Armata Rossa- ed erano sicuri che liberando dalla canaglia fascista l’Italia assolata, contribuivano ad avvicinare la liberazione della loro patria. E per quanto fosse lontana, attraverso le sventure e le distanze il suo ricordo come una voce sussurrata appena, risvegliava il loro cuore”12.

Abbabulgù Abbamagal
Nel cimitero di San Severino Marche una targa ricorda il sacrificio di un etiope di circa vent’anni caduto tra le file della Resistenza italiana: “Nato ad Addis Abeba, morto sul Monte San Vicino. Etiope partigiano del Battaglione Mario di San Severino Marche. Insieme ad altri uomini e donne provenienti da tutto il mondo, caduto per la libertà d’Italia e d’Europa”. Il suo nome era Abbabulgù Abbamagal, soprannominato “Carletto”, parte della “Banda Mario” del comandante Mario Depangher, una delle prime formazioni partigiane ad essere costituita, caratterizzata da una marcata eterogeneità: oltre a numerosi soldati alleati fuggiti dai campi di prigionia vi erano diversi combattenti d’origine araba e africana, provenienti soprattutto dal Corno d’Africa.
La ragione di questa pittoresca composizione fu la liberazione di diversi “prigionieri” dell’Africa Orientale detenuti a Villa Spada, ex-manicomio femminile a Treia, in provincia di Macerata. Questi “prigionieri” erano stati condotti in Italia dal regime fascista per un motivo molto particolare: avrebbero dovuto animare la ricostruzione di villaggi etiopi, somali ed eritrei per l’Esposizione Tematica Universale in occasione del quarto anniversario dalla fondazione dell’Impero. Le esposizioni di esseri umani provenienti dai territori coloniali erano un qualcosa di tipico in tutte le metropoli imperiali, dalla Gran Bretagna al Belgio, e servivano, mescolando curiosità antropologia a suprematismo razziale, a manifestare la grandezza dell’impero tramite la varietà delle popolazioni sottomesse. Lo scoppio della guerra e il blocco britannico di Suez impedì il rimpatrio dei “figuranti”, circa una sessantina, che si videro costretti a rimanere in Italia, sottoposti a un regime di confinamento. Da Napoli questa comunità fu infine trasferita nelle Marche.
Villa Spada non ospitava solamente i prigionieri africani, ma anche un deposito di armi e munizioni del Regio Esercito. La fuga di alcuni internati permette agli uomini della di Depangher di ottenere queste informazioni e di organizzare un’azione che, oltre a rifornire l’unità, porta al reclutamento di dodici volontari africani, tra cui Abbamagal. La loro scelta fu una di particolare coraggio. Gli internati di Villa Paradiso godevano di un regime di semilibertà, non erano minacciati da rappresaglie o violenza fisica. Avrebbero potuto tranquillamente aspettare lì la fine della guerra, come peraltro la maggior parte fece, ma quelli che decisero di unirsi alla Resistenza lo fecero perché spinti dalla volontà di riscattarsi dall’umiliazione dell’oppressione coloniale, decisi a combattere in armi il fascismo e contribuire alla liberazione dell’Italia.
La “Banda Mario” nei mesi successivi fu molto attiva, portando a compimento decine di azioni contro le truppe naziste e i collaborazionisti fascisti. In essa i combattenti africani si distinsero come particolarmente feroci. “Carletto” fu tra i primi a cadere. Il 24 novembre 1943, pochi giorni dopo la sua liberazione, Abbamagal si trovava su una macchina assieme al comandante Mario e altri due uomini quando questa venne fermata da dei soldati della Wehrmacht d’origine altoatesina. Fattosi avanti per proteggere i compagni, venne ucciso. I partigiani però ebbero la meglio: catturarono due nemici e seppellirono il corpo del caduto sulle montagne

1 G. Garibaldi, Alle genti slave sotto la dominazione austriaca ed ottomana, in Scritti e discorsi politici e militari, Vol. II, Bologna, Cappelli, 1935, pp. 124-125.
2 Marco Aurelio, Pensieri, VI, 44.
3 F. Engels, Lettera a Laura Lafargue del 20 giugno 1893.
4 F. W. Alduino, D. J. Coles, The Garibaldi Guard and Italian-American Service in the Civil War, in Italian Americana, Vol. XXII, n. 1 (aprile 2004), p. 48.
5 K. Marx, Address of the International Working Men's Association to Abraham Lincoln, President of the United States of America, 28 gennaio 1865.
6 G.Salvemini, Perché siamo andati in Libia, in Aa.Vv., Come siamo andati in Libia, Firenze, Libreria della Voce, 1914, p. XXIV.
7 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2021/11/FPS.04.001.001.002_Discorso-gennaio-1951-Livorno-Ilio-Barontini.pdf
8 https://www.youtube.com/watch?v=Z5TTiZgnoTc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.open.online%2F&source_ve_path=MjM4NTE
9 https://t.me/Andrea_lucidi/78
10 https://www.garibaldicaprera.beniculturali.it/garibaldi-e-aguyar
11 Abba G.C., Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille, Palermo, Sellerio, 1993, pp. 66-67.
12 B. Baskov, A. Zdanov, Il soldato Fedor Poletaev, Mosca, Casa editrice agenzia di stampa Novosti, 1975, pp. 292-293.
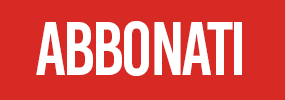

1.gif)