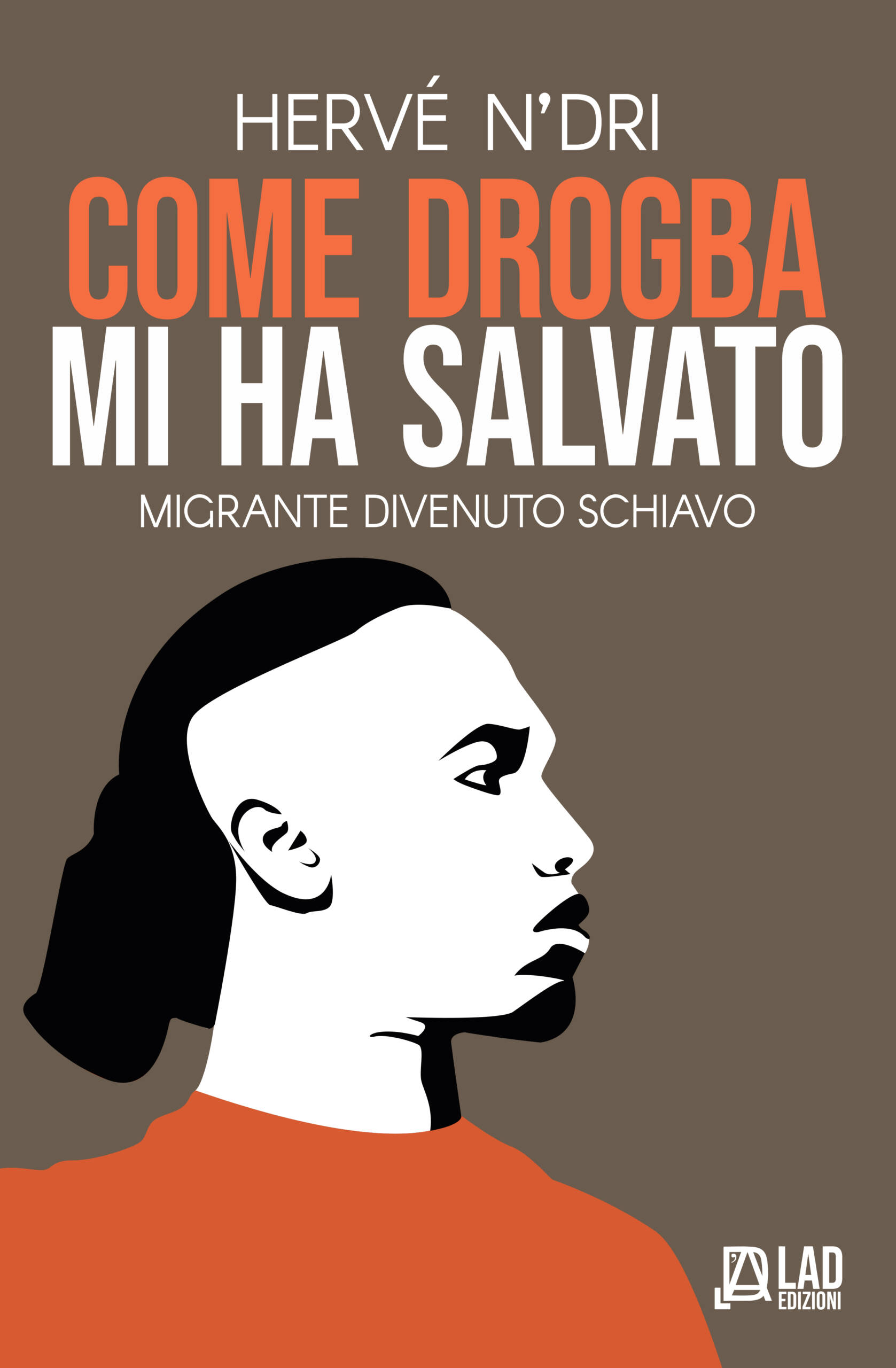Rapporto Oil sui salari: un bagno di realtà
di Stefano Macera, Emiliano Genrili, Federico Giusti
Nei giorni scorsi è uscito il Rapporto Mondiale sui salari 2025-2026, redatto dall’Oil (Organizzazione Mondiale del Lavoro). Variamente commentato sui media nostrani, è da ritenersi uno strumento prezioso. Permette infatti di farsi un’idea delle tendenze in atto su una scala globale. Particolarmente indicativa è la parte relativa all’Italia, sulla quale si sono concentrati i giornali nostrani. Certo, le testate di casa nostra non brillano per attenzione alla condizione di chi lavora, ma ciò che emerge dal Rapporto ha imposto loro di parlarne.
In Italia i salari reali sono inferiori a quelli del 2008, nell’ordine dell’8,7%. E la performance del Belpaese risulta la peggiore tra i paesi del G20. In alcuni dei quali, nello stesso lasso di tempo, i salari sono aumentati. Da noi, la tendenza negativa è stata confermata dal calo del 2022 e del 2023 (rispettivamente: –3,3% e –3,2%). Il modesto aumento registrato nel 2024 (+2,3%) non ha consentito nessun recupero rispetto al costo della vita, che negli anni immediatamente precedenti aveva toccato livelli altissimi.
Invero, dai (piccoli) segnali in controtendenza dello scorso anno è uscita rafforzata soprattutto la retorica filogovernativa. Per dire, a fine luglio 2024 il Giornale riusciva a proporre un articolo trionfalistico nel titolo (“I salari crescono e battono l’inflazione. Si riduce la distanza con il resto d’Europa”[1]) e nella sostanza. E, per dare credibilità a un discorso ai confini del favolistico, si appoggiava al verbo di un docente bocconiano: Maurizio Del Conte, professore ordinario di diritto del lavoro. Il quale si esprimeva in questi termini: «I progressi nelle retribuzioni sono la positiva conseguenza della tornata di rinnovi contrattuali (…). I lavoratori con un contratto scaduto sono scesi da circa uno su due di un anno fa a meno del 15% di oggi». E ancora, tanto per essere chiari su un rilevante tema dell’odierno dibattito: «Si tratta di dati molto confortanti (…) che confermano quanto nel nostro paese per far crescere i salari l’unica via è quella della contrattazione collettiva, con buona pace dello sterile dibattito sul salario minimo». Ora, a smentire tali discorsi è proprio la realtà degli ultimi anni. Segnata dall’accettazione, da parte delle maggiori forze sindacali, di non pochi contratti capestro.
L’obiettivo di certa stampa, pur non dichiarato, risulta evidente: sottolineare come, con il governo Meloni, si stia approdando a nuovi lidi di prosperità diffusa. Ora, smentire una siffatta propaganda non è secondario, così come risulta necessario ribadire le gravi responsabilità dei governi precedenti, diversi dei quali di centrosinistra. Tutti hanno concorso alla dinamica salariale descritta dall’Oil, così negativa da portare l’Italia a staccare, sotto questo profilo, paesi come la Spagna o quel Giappone che viene da ben 15 anni di crisi. Il picco della perdita del potere d’acquisto si è avuto nel 2022 e, da allora, miglioramenti sostanziali sono stati avvertiti solo dalle veline governative. Laddove, nella situazione nostrana di roseo non c’è nulla, se si tiene conto pure di altri fattori, come le notevoli diseguaglianze economico-sociale e di genere e il sostanziale blocco dell’ascensore sociale.
Nel Rapporto dell’Oil vi sono numerosi grafici, associati a uno studio accurato su come si sono evoluti i salari reali a livello globale. In termini generali, le economie avanzate registrano un calo degli stessi, laddove nei paesi emergenti se ne è registrata la crescita costante nel corso del tempo. Il che, per certi versi, potrebbe rimandare a un mutamento dei rapporti di forza su scala planetaria. Nonché a eventuali dinamiche conflittuali, diffuse nelle economie emergenti e poco note e studiate dalle nostre parti. Ma torniamo al nostro paese. In esso, per un buon quindicennio, si è registrata una bassa produttività, ma negli ultimi due anni qualcosa è cambiato. La produttività è cresciuta, più dei salari, tanto che i commentatori del Corriere della Sera non solo individuano lo spazio per un più serio aumento delle retribuzioni. Ma, a loro modo, mettono in evidenza l’inadeguatezza del modello vigente di contrattazione. Che assume «come riferimento un indice d’inflazione, l’Ipca, [calcolato] al netto dei prezzi dei beni energetici importati». E dunque, tale da non coprire «una delle voci che ha gravato di più sui bilanci familiari»[2]. In più, lo stesso modello rinvia «la distribuzione dei guadagni di produttività ai contratti aziendali», offrendo «questa possibilità solo a una minoranza dei lavoratori, in genere quelli delle grandi aziende»[3].
Ovviamente, a queste precisazioni del Corsera non attribuiamo un carattere risolutivo e definitivo. Sta di fatto, però, che in esse vi è la smentita di alcuni trionfalismi non solo filo o paragovernativi, ma anche legati ai sindacati meno dediti alla causa di chi lavora. Quelli, per intenderci, che non esitano a schierarsi frontalmente contro il salario minimo legale, riproponendo in altra forma i ragionamenti bocconiani poc’anzi riferiti. Al riguardo, non si può non citare Daniela Fumarola, che ha festeggiato la sua designazione a Segretaria Generale della Cisl rilasciando un’intervista al quotidiano la Repubblica[4]. Qui, ella ha ribadito che le questioni inerenti il mercato del lavoro debbono «rimanere nell’alveo della contrattazione e delle relazioni sindacali». Non solo, a suo dire una legge sul salario minimo «rischierebbe fortemente di schiacciare i salari verso il basso». Il che, se la situazione non fosse drammatica, farebbe affiorare il sorriso. Perché basta citare importanti studi di matrice istituzionale per smentire queste parole.
Per dire, nel luglio 2023 si è parlato di una ricerca della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, relativa a 63 contratti collettivi firmati da Cgil, Cisl e Uil, scelti in virtù della loro rappresentatività. Bene, dalla ricerca è emerso che, tra di essi, «ben 22, ovvero oltre un terzo, prevedono una retribuzione oraria al di sotto dei 9 euro lordi (con inclusi TFR, 13esima e 14esima)»[5]. Dunque, Fumarola non dorme la notte al pensiero del ribasso delle retribuzioni, ma si dimentica che il suo sindacato (e non solo il suo) ha contribuito a farle scendere ben al di sotto di quanto previsto nelle proposte di salario minimo legale.
Ora, con simili organizzazioni dei lavoratori non stupiscono gli altri dati che emergono dallo studio dell’Oil. Tra questi vi è il divario salariale di genere, che è pari al 9,7%. Non è, in senso assoluto, il dato peggiore dell’Ue, ma rimane uno dei più elevati, a conferma di una storica arretratezza del nostro paese. Tra le sue cause vi è la diffusa prassi del part-time involontario, che ufficialmente viene denunciata dalla Cisl, così come da Uil e Cgil. Visto il comportamento generale di queste organizzazioni, non è scontato che alle parole vibranti seguano sforzi concreti superare realmente il divario di genere. Del resto, anche attorno ai 5,6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta si producono molti bei discorsi. Da parte dei maggiori sindacati come di alcune forze politiche, che magari ora non governano e quindi si possono permettere di riscoprire occasionalmente le tematiche sociali.
Il punto è che tali questioni non possono essere affrontate separatamente. Nel Rapporto emerge anche una notevole differenza tra i salari dei lavoratori autoctoni e quelli immigrati. I secondi, rispetto ai primi, percepiscono retribuzioni inferiori del 26,3%: una divaricazione rilevante e anche preoccupante. Che può essere contrastata solo in un discorso generale, tale da porre al centro la questione salariale e la lotta contro tutte le diseguaglianze e discriminazioni. Ora, mai come oggi tale battaglia complessiva deve emanciparsi da una pericolosa illusione, rilanciata con vigore dalla Cisl e rimodulata in termini più sfumati da Cgil e Uil. Quella per cui l’erosione salariale e la costante perdita di diritti possono essere frenate attraverso la contrattazione collettiva e il dialogo sociale. A cosa abbia portato tale impostazione è ormai sotto gli occhi di tutti. Anni e anni di politica salariale moderata, spesso spinta sino all’austerità salariale vera e propria, hanno portato vantaggi al solo padronato. Laddove la classe lavoratrice e i percettori di redditi medio-bassi si confrontano quotidianamente con un netto peggioramento delle condizioni di vita, non compensato da un sistema di welfare sempre meno adeguato a rispondere ai bisogni sociali dei più. In tale contesto, occorre portare avanti pratiche collettive di difesa del potere d’acquisto dei salari e di rilancio dei servizi sociali, depauperati da anni di contenimento della spesa pubblica. In sostanza occorre tornare al conflitto, da sempre principale leva dell’emancipazione delle persone sfruttate e oppresse.
[1] Titta Ferraro, I salari crescono e battono l’inflazione. Si riduce la distanza con il resto d’Europa, 27 Luglio 2024, https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-salari-crescono-e-battono-linflazione-si-riduce-distanza-2351284.html.
[2] Enrico Marro, Salari reali, nessuno peggio dell’Italia: rispetto al 2008 perso l’8,7% del potere d’acquisto (e in Germania è salito del 15%), 25 Marzo 2025, https://www.corriere.it/economia/lavoro/25_marzo_24/salari-reali-nessuno-peggio-dell-italia-rispetto-al-2008-perso-l-8-7-del-potere-d-acquisto-e-in-germania-e-salito-del-15-8f29fe3d-5c41-4375-a665-48d02a460xlk.shtml.
[3] Ibid.
[4] Rosaria Amato, Fumarola “Siamo autonomi ma il governo è attento al dialogo Il salario minimo impoverisce”, 13 Febbraio 2024, «la Repubblica», https://www.cisl.it/notizie/attualita/siamo-autonomi-ma-il-governo-e-attento-al-dialogo-il-salario-minimo-impoverisce-la-repubblica/.
[5] Rita Querzè, Salario Minimo, i 22 contratti di Cgil, Cisl e Uil sotto i 9 euro lordi, 21 Luglio 2023, https://www.corriere.it/economia/lavoro/23_luglio_21/salario-minimo-22-contratti-cgil-cisl-uil-sotto-9-euro-lordi-infografica-63a0b664-26fc-11ee-8ff1-5e0f92474986.shtml.
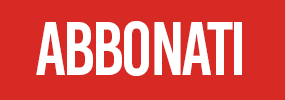

1.gif)