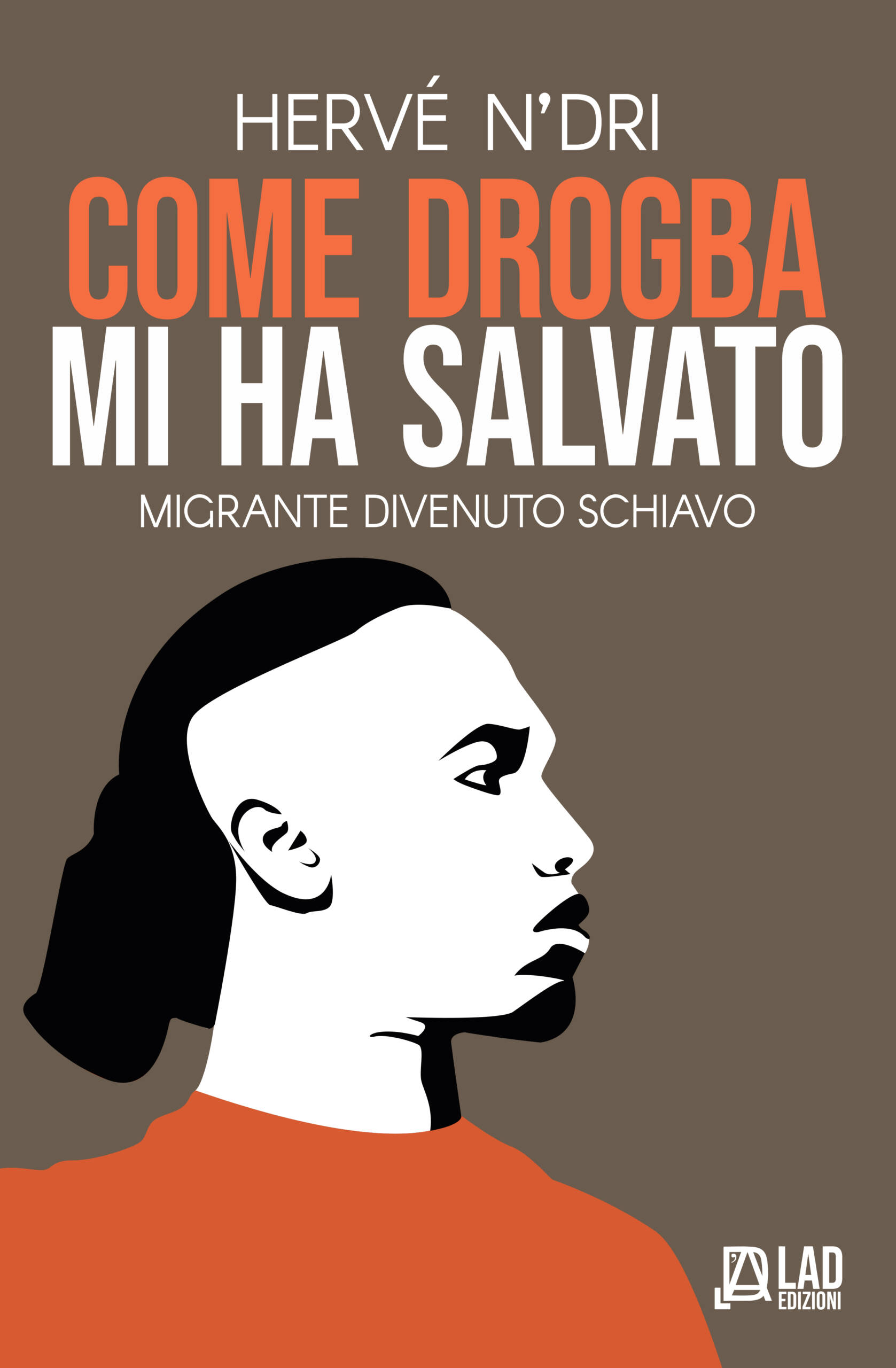Umano, fin poco umano: Leopardi e quel pensiero sui "superumani"
Nella parte conclusiva del suo poderoso studio "Nietzsche l'iperboreo", il professore Paolo Ercolani, collega il pensiero del filosofo tedesco, sul versante del superamento dell'uomo, all'attuale fase a trazione tecnofinanziaria della nostra società.
Quello che l'autore definisce come "siliconismo", pur con tutta la sua retorica libertaria e individualistica, è una ridefinizione in veste seducente del progetto nazista (e in parte fascista) di oltrepassare l'umano che si incrocia, oggi, con un l'universo tecnologico e macchinico in costante espansione tanto da poter porre all'ordine del giorno proprio il superamento dell'uomo.
Ne sono un esempio i progetti che si inoltrano con sempre più efficacia nello sviluppo dell'Intelligenza artificiale - sostenuti anche dalla forte concorrenza tra le maggiori potenze mondiali - e della robotica. Si pone davanti a noi un possibile futuro nel quale ad aggirarsi sarà lo spettro di "individui largamente composti di parti bioniche e robotiche e di coscienze umane trasferite all'interno dei computer"[1].
Citando dichiarazioni esplicite dei nuovi baroni delle tecnologie, Ercolani paventa un realistico domani nel quale agiranno macchine in grado di pensare e fare le cose meglio di noi e nel quale per l'essere umano sarà sempre più difficile lasciare un contributo. Sarà il tempo nel quale saremo assorbiti in un universo fondato sul pensiero computazionale.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad un futuro assai problematico per l'umanità che abbiamo conosciuto (e vissuto) sino ad oggi. Un incubo al quale già il poeta e filosofo Giacomo Leopardi - autore amato da Nietzsche - aveva dedicato amare e ironiche riflessioni. Pensando alla tecnica del "secolo superbo" come l'ennesima illusione destinata a perdere di fronte all'evidente divenire della realtà e alla certezza della ricaduta nel nulla, nella Proposta di premi fatta dall'Accademia dei sillografi[2], l'autore di Recanati, consapevole degli sviluppi della propria epoca e del susseguirsi di invenzioni di macchine, scrive che oramai quest'ultime "si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita". Non solo: le macchine non devono limitarsi ai lavori materiali, ma comprendere anche le "cose spirituali".
Poiché è difficile sperare che siano ancora i filosofi in grado di curare i mali del genere umano, la via preferibile sarebbe quella di rifare l'uomo tutto da capo, come in "una nuova stampa". Emendarlo è ormai impossibile ed occorre quindi superarlo. Il primo passo deve essere quello di "rimuovere" gli uomini "dai negozi della vita il più che si possa", per poi proseguire oltre: ci vuole una prima macchina in grado di fare l'amico senza biasimare, giudicare o motteggiare ma fornendo un continuo sostegno e certezza di segretezza; e poi una seconda, alimentata dalla saggezza classica di Cicerone, in grado di compiere azioni virtuose e magnanime; infine la terza in versione donna in grado di essere perfetta cortigiana e irreprensibile moglie.
Certo, le posizioni di Leopardi e di Nietzsche non sono assimilabili - ma va sottolineato che il primo ingaggia un'operazione di demolizione nei confronti della metafisica cristiana e relativizza valori ritenuti universali e modelli immutabili - ma indubbiamente il poeta italiano, pur nella sua ironia, racconta del nostro presente di solitudine nell'universo dell'ipercomunicazione: i suoi robot non sono più alimentati e programmati dagli scritti dei filosofi antichi, ma in quanto Intelligenza artificiale vampirizzano i dati, i sentimenti, gli amori, le passioni, gli odi che noi diffondiamo ogni giorno attraverso le diverse piattaforme online. Su di queste troviamo l'amico che non ci contraddice, quello che scrive per noi e la donna che si rende disponibile al consumo.
[1] Paolo Ercolani, Nietzsche l'iperboreo, il melangolo, 2022, Genova, p. 333.
[2] Giacomo Leopardi, Proposta di premi fatta all'Accademia dei sillografi in Operette morali, BUR, 1982, Milano.
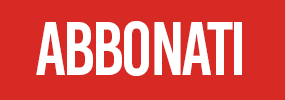

1.gif)