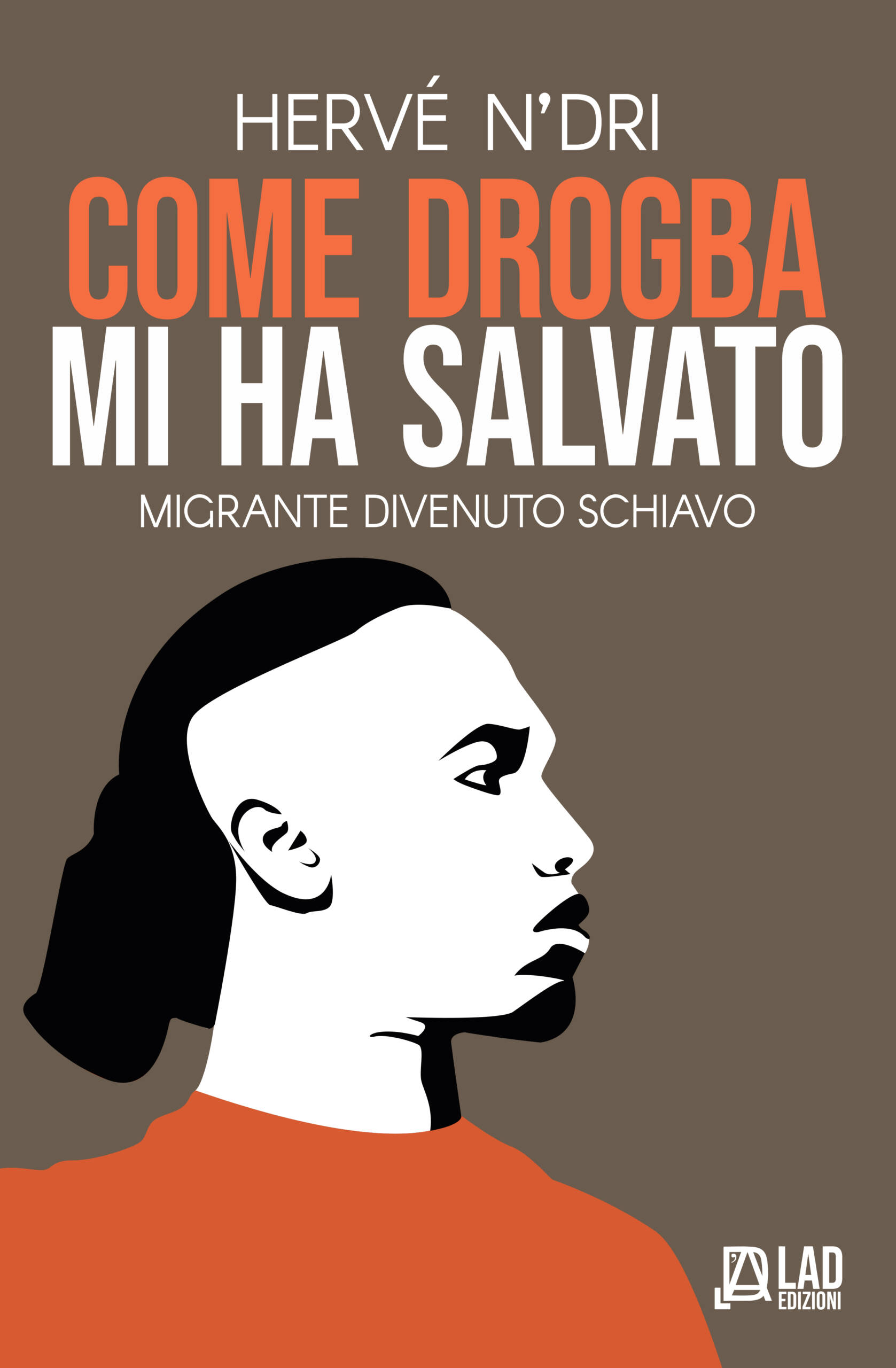"Generazione Antidiplomatica" - La bilancia e la spada: quando la legge diventa politica
Generazione AntiDiplomatica è lo spazio che l’AntiDiplomatico mette a disposizione di studenti e giovani lavoratori desiderosi di coltivare un pensiero critico che sappia andare oltre i dogmi che vengono imposti dalle classi dirigenti occidentali, colpendo soprattutto i giovani, privati della possibilità di immaginare un futuro differente da quello voluto da Washington e Bruxelles. Come costruirlo? Vogliamo sentire la vostra voce. In questo nuovo spazio vi chiediamo di far emergere attraverso i vostri contenuti la vostra visione del mondo, i vostri problemi, le vostre speranze, come vorreste che le cose funzionassero, quale società immaginate al posto dell’attuale, quali sono le vostre idee e le vostre riflessioni sulla storia politica internazionale e del nostro paese. Non vi chiediamo standard “elevati” o testi di particolare lunghezza: vi chiediamo solo di mettervi in gioco. L’AntiDiplomatico vi offre questa opportunità. Contribuite a questo spazio scrivendo quanto volete dei temi che vi stanno a cuore. Scriveteci a: generazioneantidiplomatica@gmail.com
-------------------
Articolo di Vincenzo Pellegrino, laureato in Giurisprudenza di Perugia
È giustizia o strategia? Da quando l’uomo ha scritto le prime leggi, il confine tra usarle per punire un crimine e sfruttarle per eliminare un rivale politico si è fatto sottile: un’ombra che si allunga dalla piazza di Atene ai tribunali di oggi, un filo che attraversa la storia e ci invita a guardare nelle crepe della democrazia, chiedendoci se la legge sia uno scudo per la collettività o una spada per chi comanda.
Da qui tutto inizia: nel 508 a.C., Clistene dà vita all’ostracismo. 6.000 cittadini, un quorum che dà peso al verdetto, scrivono un nome su un coccio di ceramica, e il prescelto lascia la polis per 10 anni. Non c’è processo, non ci sono accuse definite, solo un voto dell’ekklesia, l’assemblea sovrana, che stabilisce chi è troppo influente o rischioso per restare: un meccanismo pensato per proteggere la democrazia, ma consegnato alla volontà della folla. Megacle nel 486 a.C. e Santippo poco dopo vengono esiliati, sospettati di ambizioni tiranniche. Ma il sistema si trasforma presto: Temistocle, l’eroe di Salamina, spinge Aristide all’esilio per rafforzare il suo controllo, solo per essere ostracizzato a sua volta nel 470 a.C., e quando Nicia e Alcibiade si alleano per cacciare Iperbolo nel 417 a.C., l’ostracismo si rivela uno strumento di lotta politica, un processo senza un codice chiaro, aperto a chi sa pilotare l’opinione pubblica. È giustizia o strategia? È un verdetto visibile a tutti, ma fragile: senza criteri fissi o una difesa garantita, la democrazia si appoggia a un equilibrio precario, dove la folla può decidere il destino di uno senza bisogno di prove.
E non è un caso isolato: ad Atene, nel 399 a.C., Socrate affronta un tribunale di 501 cittadini, accusato di empietà e corruzione dei giovani – reati previsti dalla legge ateniese, ma vaghi nei contorni – portati avanti con un processo formale che include accuse scritte e un dibattimento. La condanna a morte, votata a maggioranza, nasce dal suo ruolo di critico dell’ordine costituito: un pensatore che con le sue domande diventa un bersaglio per chi vuole stabilità. È giustizia o strategia? La forma legale c’è, ma il sospetto che si tratti di un regolamento di conti politico si insinua: un filo che collega l’ostracismo al tribunale e ci conduce a Roma, dove la giustizia prende un’altra strada.
A Roma, nel 133 a.C., Tiberio Gracco propone una riforma agraria e viene ucciso senza passare per le quaestiones, i tribunali permanenti, accusato di aspirare alla monarchia – un’imputazione che non richiede prove, solo una reazione diretta dell’élite senatoriale. Anni dopo, tra l’82 e l’81 a.C., Silla usa le proscrizioni, un atto formalmente approvato dal Senato, per segnare migliaia di nemici da eliminare: un sistema che veste di legalità la rimozione di oppositori. E nel 63 a.C., Cicerone, con il suo “Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”, convince il Senato a giustiziare i congiurati di Catilina senza processo, scavalcando la provocatio ad populum – il diritto di appello al popolo – e appoggiandosi al senatus consultum ultimum, un decreto d’emergenza che adatta la legge alle necessità del momento. È giustizia o strategia? A Roma il diritto ha una struttura più definita rispetto ad Atene, ma senza un potere giudiziario separato si piega alle ambizioni dei senatori: un’instabilità che erode la Repubblica e apre la strada a Cesare e all’Impero, un’eco che si sente secoli dopo.
Secoli dopo, nel 1431, Giovanna d’Arco finisce davanti a un tribunale ecclesiastico controllato dagli inglesi: accusata di eresia e stregoneria – reati che includono dettagli come aver indossato abiti maschili – affronta un processo lungo mesi, regolato dalle norme inquisitoriali con interrogatori e testimoni, ma guidato dall’esigenza di neutralizzare una figura che aveva riacceso la resistenza francese. La condanna al rogo emerge da un intreccio di diritto e politica: un caso che scivola verso il XX secolo, quando i regimi prendono il sopravvento. Tra il 1936 e il 1938, Stalin avvia i processi di Mosca: Bucharin e Zinov’ev sono accusati di tradimento e cospirazione contro l’URSS – reati previsti dal codice sovietico – ma le confessioni, ottenute con pressioni e torture, e le sentenze di morte, decise da corti speciali senza possibilità di appello, servono a rafforzare il controllo centrale, un uso della legge che trova un parallelo nei regimi di destra.
E nei regimi di destra, tra il 1933 e il 1945, nella Germania nazista i Volksgerichtshof, tribunali popolari, processano oppositori come i membri della Rosa Bianca – Sophie Scholl e altri – per “alto tradimento” legato a propaganda antinazista. Le accuse si basano su leggi speciali, i procedimenti sono rapidi, senza una difesa effettiva, e le condanne a morte arrivano in poche ore: un sistema che elimina il dissenso sotto l’ombrello della legalità. In Spagna, dopo la guerra civile del 1936-1939, Franco istituisce tribunali militari che giudicano migliaia di repubblicani per “ribellione” – un capo d’accusa curioso, visto che difendevano il governo legittimo – con processi sommari che portano a esecuzioni o carcere: un meccanismo che consolida il potere attraverso la giustizia. È giustizia o strategia?
Da qui, il passo è breve: in ogni caso la legge diventa uno strumento del regime, un ponte che ci porta all’Italia degli anni ’90, quando Mani Pulite scuote il Paese. Tutto parte dall’arresto di Mario Chiesa nel 1992: Antonio Di Pietro, con il pool di Milano, usa intercettazioni e confessioni per travolgere DC e PSI con accuse di concussione e finanziamento illecito – reati ben definiti nel codice penale, applicati con un’intensità mai vista. Bettino Craxi dichiara in Parlamento “Tutti sapevano, tutti tacevano” prima di fuggire ad Hammamet, mentre 40 persone, tra politici e imprenditori, si tolgono la vita sotto il peso delle inchieste. È una rivoluzione o un’operazione mirata? La corruzione è documentata, ma il sospetto che i magistrati colpissero selettivamente – lasciando il PCI/PDS quasi intatto – e il “decreto Biondi” del 1994, un tentativo di limitare la carcerazione preventiva fermato dal pool, sollevano interrogativi. Il pool opera nei poteri del pubblico ministero, ma la scelta dei bersagli e l’impatto politico suggeriscono una direzione precisa: la Prima Repubblica crolla, e con essa la fiducia nelle istituzioni, un’onda che arriva fino al 2025.
E nel 2025, oggi, in Romania C?lin Georgescu, ultranazionalista in testa ai sondaggi, vede le elezioni del 2024 annullate dalla Corte Costituzionale per presunte ingerenze russe – un’accusa con prove limitate, senza contraddittorio pubblico – un intervento previsto dai poteri della Corte, ma che Elena Lasconi definisce “colpo alla democrazia” mentre Bruxelles annuisce. In Francia, Marine Le Pen affronta processi per finanziamenti illeciti e incitamento all’odio, reati codificati, ma il tempismo – con il Rassemblement National vicino al potere – e la vaghezza di alcune imputazioni alimentano il dubbio di una mossa politica. È giustizia o strategia?
Così, dall’ostracismo – un voto alla luce del sole – ai processi moderni – un intreccio di tecnicismi: audizioni, ricorsi, sentenze appellate – il risultato non cambia: il sospetto che la legge serva a chi detiene il potere prende piede. Non serve dimostrarlo, basta che la gente lo pensi: dall’ostracismo a Socrate, da Roma a Giovanna d’Arco, dai regimi del XX secolo a Mani Pulite, fino a Georgescu e Le Pen, ogni caso è un tassello di una storia in cui la giustizia si intreccia con la politica, non sempre per punire, ma spesso per controllare. Perché succede? Perché la giustizia non è mai stata un’entità a sé: ad Atene dipendeva dalla folla, a Roma dai senatori, nel Medioevo dalla Chiesa o dai re, nei regimi dal partito o dal leader, in Italia dai magistrati e dalle loro scelte, oggi da governi, élite o pressioni internazionali. E in un mondo diviso, ogni sentenza si trasforma in una storia da raccontare, un riflesso delle lotte di potere.
Eppure, proprio da questa storia emerge la possibilità di cambiare rotta, con strumenti che rispondano alle sue fragilità. Si potrebbe istituire un “filtro di neutralità”: un organo indipendente – composto da giuristi ed esperti eletti a rotazione, svincolati da governi o fazioni – incaricato di vagliare le accuse prima che arrivino al giudizio, distinguendo prove solide da sospetti vaghi, come quelli che colpirono Tiberio Gracco o Georgescu, per arginare l’arbitrio della folla o delle élite. O ancora, un “codice anti-vaghità”: una normativa che obblighi ogni reato a essere definito con precisione, con una lista pubblica di elementi costitutivi verificabili – niente più “empietà” o “tradimento” lasciati all’interpretazione – dando a figure come Socrate o Sophie Scholl un terreno legale chiaro su cui difendersi. E se la trasparenza fosse la chiave? “Finestre di verità” potrebbero rendere i procedimenti cruciali accessibili a tutti, con trasmissioni pubbliche e un portale digitale di atti e testimonianze, per evitare le ombre delle confessioni forzate di Stalin o dei processi sommari. Infine, un “veto popolare”: una norma che, con il 10% delle firme dei cittadini, permetta di riesaminare casi controversi – da Mani Pulite a Le Pen – davanti a un collegio giudicante straordinario, isolato da pressioni politiche, per restituire alla collettività un ruolo di controllo. Il potere cercherà sempre di insinuarsi, è vero: ma questi strumenti, nati dalle crepe della storia, potrebbero spostare la giustizia dal campo delle armi a quello degli scudi, rendendola meno preda di chi comanda e più baluardo per tutti.
E così, i sistemi moderni offrono garanzie – diritto alla difesa, appello, presunzione d’innocenza – ma quando il sospetto politico le attraversa, diventano un’armatura di carta. La democrazia ne esce indebolita, non solo per gli abusi, ma per l’idea che la bilancia non pesi allo stesso modo per tutti: una fragilità che non è un’eccezione, ma una costante della storia, un’erosione lenta che nasce dalla tensione tra legge e potere. Può la democrazia resistere se la giustizia diventa un’estensione della politica? La storia mostra un costo pesante: Atene perde Socrate e la sua purezza, Roma scivola verso l’Impero, Giovanna finisce in cenere, i regimi schiacciano i loro oppositori, l’Italia cambia ma non guarisce, e oggi il dubbio resta un compagno silenzioso. Nel 2025, siamo qui, a chiederci se quel confine tra diritto e potere sia mai stato solido, una linea che si sposta con il vento della storia.
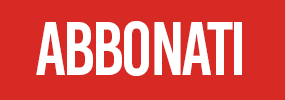

1.gif)